di Marco Valle, Secolo d'Italia
Qualche
anno fa Paolo Nicoloso, studioso di storia dell’architettura del
Novecento, nel suo “Mussolini architetto, propaganda e paesaggio urbano
nell’Italia fascista” (Einaudi) — un lavoro importante, critico e non
inutilmente fazioso —, fu costretto ad ammettere che: «in Italia, il
senso di appartenenza a una comunità nazionale è assai debole e il
patrimonio architettonico è una straordinaria risorsa su cui costruire
le basi dell’identità. Ma proprio a questo scopo l’architettura è stata
utilizzata dal fascismo in modo eccellente, come mai nessuna nazione
moderna aveva fatto… di nuovo, “l’arcana potenza” di quest’arte ritorna a
produrre suggestioni collettive. Alla fine, il disegno di Mussolini, di
parlare ai posteri del fascismo attraverso l’architettura, appare
dunque vincente».
Una
valutazione forte che sollevò a sinistra — la destra, come al solito,
era in altre cose affaccendata…— un dibattito importante. Su
“Liberazione” Lucia De Vezio scrisse una densa recensione dell’opera di
Nicoloso, significativamente intitolata “Sta vincendo Mussolini?”
ricordando, in primis, che già «Piero Della Seta e Roberto Della
Seta in un testo fondamentale (“I suoli di Roma”, Editori riuniti, 1988)
hanno analizzato approfonditamente la politica fondiaria del fascismo,
smentendo le interpretazioni correnti circa la continuità fra
l’urbanistica fascista e quella dei governi democristiani, arrivando a
concludere che “lo strapotere della grande rendita fondiaria è una
novità del dopoguerra, non del fascismo”. L’emancipazione dagli
interessi speculativi è stata evidentemente una condizione essenziale
per consentire all’architettura di svolgere al meglio quella funzione
rappresentativa e simbolica che Mussolini le attribuiva». La De Vezio
concludeva, concordando con l’autore, che «amaramente si registra una
sorta di rivincita del fascismo, a partire proprio dall’architettura. È
in sostanza la presa d’atto di una più generale crisi della cultura e
della politica (a cominciare da quelle di sinistra) che non hanno saputo
fornire all’opinione pubblica italiana, e ai giovani soprattutto,
un’alternativa efficace alla “fascinazione” fascista».
Qualche
tempo dopo, Paolo Portoghesi — antico incendiario postmoderno e oggi
pompiere accademico —, ammise in un suo articolo su “L’Osservatore
Romano” — sic transit…— non solo il valore del libro di Nicoloso
ma anche, con qualche inevitabile banalità, le ragioni di Mussolini
“architetto e urbanista” e soprattutto riconoscendo, finalmente, che «i
razionalisti italiani, i critici come Bardi, Bontempelli, Belli e gli
architetti come Pagano, Terragni, Moretti, erano dei convinti fascisti e
tentavano la difficile impresa di italianizzare e quindi fascistizzare
il razionalismo puntando sulla radice “mediterranea” e sulla vocazione
mistica dell’astrattismo. Alcuni, come Michelucci, Cosenza e anche
Pagano, cercavano radici e archetipi nella modernità della tradizione
popolare dell’architettura senza architetti».
Insomma,
una rivalutazione imbarazzata ma piena del grande sforzo modernizzatore
dell’esperienza mussoliniana che, come ricorda proprio Portoghesi, ha
rivelato «la capacità di definire una forma urbana che, nonostante la
magniloquenza, si è rivelata adatta alle esigenze della vita collettiva
assai più di certi quartieri del dopoguerra, ispirati dalla retorica
collettivista».
Al
tempo stesso, sulla scia del successo dei libri di Pennacchi sulle
bonifiche pontine e le “città di fondazione” e, soprattutto, della sua
lettura, magari confusa ma innovativa, della dialettica città-campagna,
ruralismo-industrializzazione del sulfureo ventennio, la polemica sui
meriti o demeriti della politica architettonica e urbanistica del regime
si è ravvivata e arricchita. Ma non solo. In questi anni — nel silenzio
dell’ex destra di governo, imbarazzata dinanzi a questa inattesa
“rivincita mussoliniana” — sempre più storici hanno iniziato, con gran
disappunto di vetero azionisti torinesi come De Luna e Revelli, ad
indagare i tanti aspetti misconosciuti della modernizzazione autoritaria
italiana. Senza sconti e senza paraocchi.
Pensiamo,
ad esempio, ai saggi di Eugenio di Rienzo ed Emilio Gin sulla
diplomazia fascista e le intricate problematiche del periodo bellico, ai
lavori di Marino Ruzzenenti e Mauro Canali sulle politiche energetiche
mussoliniane o alla ricerca di Stefano Pisu sulla cinematografia e i
rapporti culturali italo-sovietici.
Un laboratorio futurista tra le Apuane e il Tirreno
L’elenco
potrebbe continuare ma preferiamo fermarci e riflettere su un libro
decisamente interessante: “Apuania, provincia di fondazione” di Paolo
Camaiora (Eclettica edizioni, Massa, 2013. Ppgg. 200 – euro 25,00).
L’autore, carrarese Doc, è un architetto innamorato del razionalismo e
della sua terra e, fortunatamente, poco attento ai dettami del
“politicamente corretto”. Supportato da un ricco apparato iconografico e
documentale, Camaiora ha indagato, intrecciandoli — in un viaggio
interdisciplinare, secondo l’insegnamento di Bloch e Braudel — i
mutamenti sociali e politici e le politiche urbanistiche e
amministrative della provincia di Massa e Carrara nel periodo tra le due
guerre. Una scelta adeguata e intelligente, purtroppo appesantita un
eccesso di vis polemica che rischia di penalizzare inutilmente un lavoro altresì serio e importante.
In ogni
caso, ripercorrendo le vicende di questo frammento d’Italia il lettore
di cultura non ovvia, accanto e oltre alla storia locale, troverà
ulteriori lenti per comprendere le logiche e le dinamiche che
sottintesero l’imponente sforzo di modernizzazione e razionalizzazione
dell’Italia attuato dal regime.
Facciamo
un passo indietro. Negli anni Venti, complice la grande crisi mondiale,
l’antico dominio estense si era ridotto ad un’area depressa,
terribilmente povera e sempre incatenata all’oscillante economia
marmifera. Per di più, nonostante i mutamenti politici, il territorio
rimaneva straziato dalle tensioni municipaliste tra Massa e Carrara e
avvelenato da solidi rancori sociali. Una situazione insostenibile per
l’Italia “fascista e proletaria”.
Su
impulso di Renato Ricci, capofila del fascismo locale e allora
Presidente dell’Opera Nazionale Balilla, e di Osvaldo Sebastiani, nel
1937 fu decisa la realizzazione di una grande zona industriale — il
piano Sebastiani — a cavallo tra le due città e, nel ’38, venne
istituita la ZIA (Zona Industriale Apuana). In tempi record furono
sistemati e bonificati i terreni, canalizzati fiumi e torrenti, posati
binari, costruite banchine e, subito dopo, innalzati gli stabilimenti.
Nell’arco di pochi anni, circa sessanta aziende — attratte dai generosi
sgravi fiscali — s’impiantarono nel distretto e ottomila persone
trovarono lavoro.
Un
successo pieno a cui corrispose un parallelo piano urbanistico che
prevedeva la fusione dei tre centri interessati — Carrara, Massa e
Montignoso — in un unico nuovo comune, Apuania. Come sottolinea l’autore
«nel caso specifico, l’ambizioso progetto di sviluppo non prevedeva
soltanto quello industriale, ma anche quello abitativo. La fusione delle
tre città in una sola, la realizzazione dei viali a mare e dei viali
perpendicolari alla costa, le reti viarie secondarie, altro non erano
che assi di demarcazione dello sviluppo urbano del territorio dove,
però, ferree erano le disposizioni in materia di costruzione e di
edificabilità».
Sotto
la supervisione di Ricci — che, da uomo intelligente, si avvalse dei
consigli di Enrico del Debbio, l’architetto del Foro Mussolini a Roma, e
dallo scultore Arturo Dazzi — il paesaggio cambiò volto e fisionomia.
Il piano regolatore dell’epoca, parzialmente realizzato e nel dopoguerra
stravolto, esprimeva «insieme con una visione moderna dell’assetto
territoriale, anche un’idea dei rapporti sociali: le case economiche
localizzate in aree vicine alle attività produttive o nelle fasce più
interne, mentre villini e palazzine collocate sugli assi viari
principali». Gran parte dei progetti rimasero sulla carta, ma gli
edifici realizzati a Carrara — il Palazzo delle Poste e la sede della
Gioventù Italiana del Littorio — e a Massa — i grandi stabilimenti della
Zona Industriale—, le colonie marine sulla costa e i nuovi borghi delle
zone bonificate, testimoniano tutt’oggi l’ampiezza e la forza
innovativa del progetto.
Nel
1938, a sigillo e garanzia del piano di sviluppo, il governo fascista
volle chiudere in modo drastico le diatribe municipaliste e decise non
solo d’unificare, come sopra accennato, i tre centri maggiori in un
unico grande Comune, ma di fondare una nuova Provincia, anch’essa di
nome Apuania. Una scelta coraggiosa che seppelliva polemiche passatiste,
razionalizzava funzioni e servizi e formava un’area socio-economica
organica e funzionale al sistema Italia. Come nota Camaiori, Apuania fu
«la risultante di un’operazione futurista, cioè proiettata nel futuro,
partendo dal risolvere il dato oggettivo, sociale, della povertà che
affliggeva la popolazione».
L’esperienza
ebbe vita breve. Nel 1946, uno degli ultimi atti d’Umberto di Savoia fu
proprio la cancellazione dell’effimera “Provincia di Fondazione”. Da
allora, sotto le Apuane si tornò all’ordinamento post unitario e il
vecchio, misero municipalismo — un impasto di grettezza, invidie e
“pensieri corti” — ritrovò da spazio e fiato.
Di quel
tempo ormai lontano e irripetibile restano, in Toscana come ovunque in
Italia e nelle antiche colonie, le architetture. Gli edifici, le opere.
Sono simboli potenti, che sfidano gli anni, i secoli. Come teme Nicolosi
«le loro forme sono concepite per non essere consumate come moda
passeggera, bensì per resistere nel tempo ed essere attuali “anche tra
400 anni”. L’architettura “con la sua costante presenza, modifica a poco
a poco il carattere delle generazioni”, si legge nel Dizionario del
fascismo, testo ufficiale del PNF. Essa dovrà ravvivare, per chi la
vede, al tempo di Mussolini o tra qualche centinaio d’anni, un
sentimento di appartenenza a una civiltà italiana e fascista, antica e
superiore». Parole su cui riflettere.







.jpg)









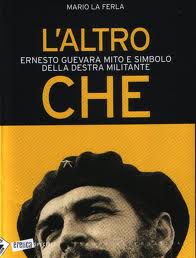 È per questo motivo che la
figura simbolica di Ernesto Guevara è sopravvissuta alla sua morte,
alla fine del comunismo, al lento disfacimento della rivoluzione cubana e
al crollo delle ideologie. Ed è per lo stesso motivo che il guerrillero heroìco
viene ricordato persino da chi, apparentemente, si trova agli antipodi
della sua parabola politica. Come ha sottolineato anni fa Mario
La Ferla nel volume “L’altro Che” (Stampa Alternativa), già da molti
anni gruppi culturali e formazioni politiche di destra hanno rivalutato
la figura del guerrigliero argentino.
È per questo motivo che la
figura simbolica di Ernesto Guevara è sopravvissuta alla sua morte,
alla fine del comunismo, al lento disfacimento della rivoluzione cubana e
al crollo delle ideologie. Ed è per lo stesso motivo che il guerrillero heroìco
viene ricordato persino da chi, apparentemente, si trova agli antipodi
della sua parabola politica. Come ha sottolineato anni fa Mario
La Ferla nel volume “L’altro Che” (Stampa Alternativa), già da molti
anni gruppi culturali e formazioni politiche di destra hanno rivalutato
la figura del guerrigliero argentino.

