tratto da Barbadillo.it
L’Italia “periferia” d’Europa? Secondo il Fondo monetario internazionale sì. Continua l’operazione “attacco” da parte dell’Fmi
che – tra un’ingerenza e una bacchettata al nostro Paese – si ostina a
tracciare dell’Italia un profilo degradato e falso. Prima il “divieto”
di tagliare una tassa iniqua come l’Imu, mentre adesso è arrivato il
rapporto annuale, dove il nostro Paese è stato inglobato e classificato
fra le peripheral country, ossia i “paesi periferici” dell’Eurozona.
Dopo i “Pigs” insomma, l’acronimo volgare e razzista
(significa “maiali”) con cui per anni sono stati definiti i paesi in
“difficoltà” dell’Ue (ossia Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e
Portogallo), arriva adesso la mappa delle organizzazioni sovranazionali
che in qualche modo intendono ridisegnare l’Europa. Non a caso, infatti,
il continente viene diviso in due settori: una parte centrale virtuosa
di serie A (con le nazioni “core” ossia Germania, Francia, Austria,
Olanda) e il resto considerato periferia, ossia Europa di serie B.
A nulla sono valse le proteste da parte dell’Ue: il
rapporto rimane così com’è stato concepito, con tutte le implicazioni
politiche ed economiche che susciterà dato che il rating di un Paese
risente molto della reputazione che questo possiede in seno alle
organizzazioni finanziarie.
Per l’Fmi, dunque, il nostro Paese sarebbe addirittura tra quelli “sottosviluppati”,
alla stregua di Grecia e Portogallo le cui economie versano in
condizioni oggettivamente complesse ma mai paragonabili a quelle
dell’Italia. Un’indicizzazione, questa, che – evidentemente – non tiene
conto della realtà oggettiva di un Paese del G7 e della terza economica
d’Europa.
Con tutta probabilità, allora, trattasi di un‘“aspirazione”
da parte di una certa finanza che vede la già traballante Unione
europea e tutta l’Eurozona come un’area da poter aggredire. Perché
un’Europa divisa – con tutta la sua storia e il suo impianto sociale –
può fare solo comodo alla speculazione internazionale.
mercoledì 31 luglio 2013
lunedì 29 luglio 2013
11 AGOSTO: CASAGGì AL SACRARIO DELLA RSI DI TRESPIANO!
Come ogni anno,
l'11 di agosto, porteremo un fiore sulla tomba dei caduti della Repubblica Sociale Italiana, al sacrario di Trespiano. Lo faremo nel
giorno della "liberazione" di Firenze, per rendere simbolicamente
omaggio a chi, fino all'ultimo respiro, ebbe il coraggio di opporsi
all'invasione anglo-americana. Lo faremo in silenzio, senza simboli
politici, perchè riteniamo quel sacrificio, dimenticato e oltraggiato da
decenni di menzogne e di calunnie, appartenga alla storia di tutto il
nostro Popolo.
E, come ogni anno,
riportiamo in calce il brano di Malaparte, tratto da "La Pelle", nel
quale si racconta della fucilazione di alcuni ragazzi sul sagrato della
chiesa di Santa Maria Novella. Un episodio taciuto dalle cronache
storiche, ma assolutamente vero e non privo di spunti di riflessione...
Domenica 11 agosto l'appuntamento è alle ore 11 al cimitero di Trespiano. Esserci, nonostante la stagione, sarà un atto di memoria, di condivisione e di identità.
DA "LA PELLE" DI CURZIO MALAPARTE:
I ragazzi seduti
sui gradini di S. Maria Novella, la piccola folla di curiosi raccolta
intorno all’obelisco, l’ufficiale partigiano a cavalcioni dello sgabello
ai piedi della scalinata della chiesa, coi gomiti appoggiati sul
tavolino di ferro preso a qualche caffè della piazza,la squadra di
giovani partigiani della divisione comunista “Potente", armati di mitra e
allineati sul sagrato davanti ai cadaveri distesi alla rinfusa l’uno
sull’altro, parevano dipinti da Masaccio nell’intonaco dell’aria grigia.
Illuminati a picco dalla luce di gesso sporco che cadeva dal cielo
nuvoloso, tutti tacevano, immoti, il viso rivolto tutti dalla stessa
parte. Un filo di sangue colava giù per gli scalini di marmo.
I fascisti seduti
sulla gradinata della chiesa erano ragazzi di quindici o sedici anni,
dai capelli liberi sulla fronte alta, gli occhi neri e vivi nel lungo
volto pallido. Il più giovane, vestito di una maglia nera e di un paio
di calzoni corti, che gli lasciavano nude le gambe dagli stinchi magri,
era quasi un bambino.
C’era anche una
ragazza fra loro: giovanissima, nera d’occhi, e dai capelli, sciolti
sulle spalle, di quel biondo scuro che s’incontra spesso in Toscana fra
le donne del popolo, sedeva col viso riverso, mirando le nuvole d’estate
sui tetti di Firenze lustri di pioggia, quel cielo pesante e gessoso, e
qua e là screpolato, simile ai cieli del Masaccio negli affreschi del
Carmine.
Quando avemmo udito
gli spari, eravamo a metà via della Scala, presso gli Orti Oricellari.
Sboccati sulla piazza, eravamo andati a fermarci ai piedi della
gradinata di Santa Maria Novella, alle spalle dell’ufficiale partigiano
seduto davanti al tavolino di ferro.
Al cigolio dei
freni delle due jeep, l’ufficiale non si mosse, non si voltò. Ma dopo un
istante tese il dito verso uno di quei ragazzi, e disse:
- Tocca a te. Come ti chiami?
- Oggi tocca a me - disse il ragazzo alzandosi - ma un giorno o l'altro toccherà a lei.
- Come ti chiami ?
- Mi chiamo come mi pare... - O che gli rispondi a fare a quel muso di bischero, gli disse un suo compagno seduto accanto a lui.
- Gli rispondo per
insegnargli l'educazione, a quel coso - rispose il ragazzo, asciugandosi
col dorso della mano la fronte madida di sudore. Era pallido, e gli
tremavano le labbra. Ma rideva, con aria spavalda guardando fisso
l'ufficiale partigiano.
A un tratto i ragazzi presero a parlar fra loro ridendo.
Parlavano con l'accento popolano di San Frediano, di Santa Croce, di Palazzolo.
L’ufficiale partigiano alzò la testa e disse:
- Fa presto. Non mi far perdere tempo. Tocca a te.
- Se gli è per non
farle perdere tempo - disse il ragazzo con voce di scherno - mi sbrigo
subito - E scavalcati i compagni andò a mettersi davanti ai partigiani
armati di mitra, accanto al mucchio di cadaveri, proprio in mezzo alla
pozza di sangue che si allargava sul pavimento di marmo del sagrato.
- Bada di non sporcarti le scarpe ! - gli gridò uno dei suoi compagni, e tutti si misero a ridere.
- Jack e io saltammo giù dalla jeep.
- Stop! - urlò Jack.
Ma in quell’istante il ragazzo gridò: - Viva Mussolini ! - e cadde crivellato di colpi .
venerdì 26 luglio 2013
La Farnesina colleziona gaffe. Manchiamo di sovranità nazionale...
Marco Petrelli intervista Pietrangelo Buttafuoco...
Ciò che emerge dall'intervista è un'immagine piuttosto confusa del
nostro Paese nell'ambito delle relazioni internazionali. L'Italia,
secondo il giornalista catanese, mancherebbe di autonomia decisionale e
di autorevolezza nei confronti degli interlocutori alleati o no.
Che idea si è fatto del caso Ablyazov?
Sospetto che la questione sia solo un regolamento di conti. Dal
Kazakhistan deriva il nucleo centrale del gasdotto russo. L'Italia, con
Berlusconi, scelse questa opzione. Fu conveniente perché dimezzò i costi
ma agli alleati americani non è andata giù. Hanno perso molti soldi nel
mancato affare.
Alfano dovrebbe dimettersi secondo lei?
E dunque anche Bonino? E poi i vertici delle amministrazioni? Vedrà che
finirà con una relazione esauriente e chiara in un punto: farla pagare
ai sottoposti.
E' forse mancato un coordinamento tra Viminale e Farnesina?
Non ho idea. Non voglio neppure farmela.
Cosa ne pensa di Emma Bonino agli Esteri?
E' un ottimo ufficiale di collegamento tra la colonia Italia e il Pentagono
Che impressione si è fatto della politica estera italiana?
La Farnesina ha collezionato tutta una serie di gaffe. Ancora prima dei
marò c'è la vicenda di Mario Vattani, il diplomatico richiamato da Osaka
perché colpevole di lesa canzone quando il governo del Giappone
dimostra considerazione e stima per lo stesso, uno dei pochi in grado di
conoscere a fondo Tokio e tutte le complessità del mercato nipponico.
Dalla vicenda dei due marò a oggi si aggiunge, passando per la
tragicomica vicenda del presidente della Bolivia cui l'Italia, l'effetto
di un cancro conclamato. Quello di non avere sovranità politica.
Perché?
L'Italia è un'espressione geografica. Tutto qua.
Turchia ed Egitto: secondo lei le rivolte dei due paesi sono simili quanto a contesto e modalità?
No. In Turchia c'è una vivacità di ambiente cosmopolita che l'Egitto non
ha. Quest'ultimo è più facile preda delle influenze straniere, sia nel
versante dei buoni, sia in quello dei cattivi.
Come dovrebbe comportarsi l'Italia nelle sue relazioni con Ankara e Il Cairo?
Come uno stato sovrano la cui politica estera è dettata dagli interessi nazionali.
giovedì 25 luglio 2013
Cent’anni fa nasceva Pino Romualdi. Un ricordo che suona come un monito per la destra in crisi d’identità...
di Massimiliano Mazzanti (Secolo d'Italia)
«Gli uomini – diceva sempre lui, quando era chiamato a omaggiare un amico passato nella schiera dei più – non si commemorano, si ricordano». E ricordare Pino Romualdi – vicesegretario del Pfr e fondatore del Movimento sociale italiano – nel 100° anniversario della nascita, in un momento d’indubbia difficoltà della Destra politica italiana, può e deve essere il monito a non abbandonarsi alla rassegnazione. Nato a Dovia di Predappio il 25 luglio del 1913, Romualdi, come tanti giovani della sua generazione, ebbe il destino segnato dalla storia, dalla contemporaneità dei grandi eventi della storia italiana, dal Fascismo, dalla gigantesca figura di Benito Mussolini.
Una vita, quindi, votata alla costruzione di una Patria rinnovata, dall’impegno politico e intellettuale intenso, dalla volontaristica concezione dell’esistenza e dai sacrifici bellici. Incaricato di pensare il futuro di chi, nella temperie della Repubblica sociale, sarebbe uscito inevitabilmente sconfitto dalla guerra, Romualdi compì il suo primo capolavoro politico strappando a Palmiro Togliatti l’amnistia per i fascisti in galera, prima; poi, riunendo queste provate forze sopravvissute al conflitto in un partito destinato a svolgere ancora un ruolo nella lotta politica, il Msi. Arrestato nel 1948 e detenuto fino al 1951, rientrò a pieno ritmo nell’agone, instradando le migliori e più giovani energie del Movimento lungo la strada che, tra mille difficoltà e ritrosie anche tra i camerati e gli amici, avrebbe dovuto trasformare il Msi in un moderno partito di destra, schierato saldamente nel fronte internazionale anticomunista e in perenne competizione con la Democrazia cristiana per la rappresentanza degli interessi e delle aspirazioni delle classi produttrici della borghesia e del lavoro italiani. Punto di riferimento per tutti, anche per lo stesso Giorgio Almirante, nei momenti di crisi – a partire da quella gravissima determinata dalla scissione di Democrazia nazionale – impose alla Fiamma di non scivolare mai nel nostalgismo, nel facile e sicuro rifugio delle rimembranze; per Romualdi la strada maestra era e doveva restare sempre l’accettazione delle sfide della contemporaneità, la capacità di vivere pienamente il proprio tempo. Alla guida del primo Eurogruppo a Strasburgo – con lo stesso Almirante e gli indimenticabili Franco Petronio e Nino Buttafuoco – dette, quindi, al Msi-Dn un respiro internazionale, conquistando al partito un rispetto che andava oltre gli stessi confini nazionali. Legato ad Almirante nella vita e nella lotta politica, in un rapporto fatto anche di aspre contrapposizioni, morirono anche insieme, a 24 ore di distanza l’uno dall’altro, tra il 21 e il 22 maggio 1988. Dunque, Romualdi non vide la nascita di Alleanza nazionale, ma fu principalmente a lui, al suo pensiero, alla sue grandi intuizioni che la generazione successiva si ispirò per costruire la nuova casa della Destra. Un’ispirazione che andrebbe nuovamente nutrita e coltivata.
«Gli uomini – diceva sempre lui, quando era chiamato a omaggiare un amico passato nella schiera dei più – non si commemorano, si ricordano». E ricordare Pino Romualdi – vicesegretario del Pfr e fondatore del Movimento sociale italiano – nel 100° anniversario della nascita, in un momento d’indubbia difficoltà della Destra politica italiana, può e deve essere il monito a non abbandonarsi alla rassegnazione. Nato a Dovia di Predappio il 25 luglio del 1913, Romualdi, come tanti giovani della sua generazione, ebbe il destino segnato dalla storia, dalla contemporaneità dei grandi eventi della storia italiana, dal Fascismo, dalla gigantesca figura di Benito Mussolini.
Una vita, quindi, votata alla costruzione di una Patria rinnovata, dall’impegno politico e intellettuale intenso, dalla volontaristica concezione dell’esistenza e dai sacrifici bellici. Incaricato di pensare il futuro di chi, nella temperie della Repubblica sociale, sarebbe uscito inevitabilmente sconfitto dalla guerra, Romualdi compì il suo primo capolavoro politico strappando a Palmiro Togliatti l’amnistia per i fascisti in galera, prima; poi, riunendo queste provate forze sopravvissute al conflitto in un partito destinato a svolgere ancora un ruolo nella lotta politica, il Msi. Arrestato nel 1948 e detenuto fino al 1951, rientrò a pieno ritmo nell’agone, instradando le migliori e più giovani energie del Movimento lungo la strada che, tra mille difficoltà e ritrosie anche tra i camerati e gli amici, avrebbe dovuto trasformare il Msi in un moderno partito di destra, schierato saldamente nel fronte internazionale anticomunista e in perenne competizione con la Democrazia cristiana per la rappresentanza degli interessi e delle aspirazioni delle classi produttrici della borghesia e del lavoro italiani. Punto di riferimento per tutti, anche per lo stesso Giorgio Almirante, nei momenti di crisi – a partire da quella gravissima determinata dalla scissione di Democrazia nazionale – impose alla Fiamma di non scivolare mai nel nostalgismo, nel facile e sicuro rifugio delle rimembranze; per Romualdi la strada maestra era e doveva restare sempre l’accettazione delle sfide della contemporaneità, la capacità di vivere pienamente il proprio tempo. Alla guida del primo Eurogruppo a Strasburgo – con lo stesso Almirante e gli indimenticabili Franco Petronio e Nino Buttafuoco – dette, quindi, al Msi-Dn un respiro internazionale, conquistando al partito un rispetto che andava oltre gli stessi confini nazionali. Legato ad Almirante nella vita e nella lotta politica, in un rapporto fatto anche di aspre contrapposizioni, morirono anche insieme, a 24 ore di distanza l’uno dall’altro, tra il 21 e il 22 maggio 1988. Dunque, Romualdi non vide la nascita di Alleanza nazionale, ma fu principalmente a lui, al suo pensiero, alla sue grandi intuizioni che la generazione successiva si ispirò per costruire la nuova casa della Destra. Un’ispirazione che andrebbe nuovamente nutrita e coltivata.
mercoledì 24 luglio 2013
“Manif pour tous” arriva in Italia: “No al bavaglio per chi difende la famiglia”...
di Barbadillo.it
Una pagina facebook appena nata a presa d’assalto in poche ore, una
uscita pubblica in programma per giovedì a Roma sullo stile dei
Veilleurs e la prima maglietta ufficiale. “Manif pour tous” sbarca in
Italia. Non (solo) in segno di solidarietà alla “primavera francese” che
si sta consumando oltralpe contro la legge Taubira e che sta
risvegliando la volontà di partecipazione di gran parte dei giovani
francesi che occupano da mesi le piazze contro le politiche antisociali
del governo Hollande. Ma proprio perché anche in Italia, come denunciano
i promotori, sarebbe in atto un tentativo analogo non solo di
liberalizzazione del matrimonio per le coppie omosessuali ma anche
l’eventualità di un vero e proprio reato d’opinione dietro le norme sul
contrasto all’omofobia.
Come spiegano i fondatori del sodalizio italiano nel comunicato, «il 18
giugno 2013 è stato avviato l’iter legislativo al Senato della
Repubblica sulla proposta di legge per l’accesso al matrimonio da parte
delle coppie formate da persone dello stesso sesso (chiamata “Matrimonio
egualitario”). Inoltre, nel cassetto c’è anche quella della
Modificazione dell’attribuzione di sesso». Il punto delicato, assieme a
questo, riguarda proprio «la discussione della legge in “Contrasto
all’omofobia e alla transfobia” proposta dal deputato Ivan Scalfarotto
(Pd) come integrazione della Legge Mancino Reale» che istituisce «tra i
reati che persegue, il crimine legato alla discriminazione di genere,
punendolo con il carcere. È quindi una vera e propria legge bavaglio».
Bavaglio per un motivo in particolare: «Se pubblicamente si dichiara che
il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia paragonabile a
quello tra uomo e donna (sulla proposta di legge giocano sul concetto di
“idee fondate sulla superiorità”)», potrebbe accadere che questa
affermazione potrebbe «essere benissimo letta come una discriminazione,
se non addirittura un incitamento alla violenza, verso le persone
omosessuali, cosa che può portare al carcere fino a quattro anni». Un
po’ come già accade in Francia, dove episodi di censura (e anche di
violenza) delle forze dell’ordine contro manifestanti pacifici di Manif
pour tous hanno richiamato l’attenzione delle stesse istituzioni
europee.
Secondo l’associazione «è chiaro che questa prima proposta è un cavallo
di troia per far passare senza troppa fatica le altre due proposte di
legge, compresa l’adozione da parte delle persone dello stesso sesso.
Nella proposta di legge sul “Matrimonio egualitario” c’è l’esplicita
volontà di sostituire le parole “marito e moglie” con la parola
“coniugi”. Insomma, una vera decostruzione di ciò che da sempre ed in
tutte le culture è stato considerato il cardine della società umana, la
famiglia fondata tra un uomo ed una donna». Per protestare contro tutto
questo si sono dati appuntamenti giovedì a Montecitorio dove, a partire
dalle 19, «verrà distribuita a tutti i partecipanti una candela da
utilizzare durante la veglia, come richiamo a non spegnere la propria
coscienza». Inoltre i promotori consigliano «di portare anche un
bavaglio, a ricordare che la libertà di pensiero e di parola può sempre
essere a rischio».
L’obiettivo di Manif pour tous, insomma, è quello di far nascere anche
in Italia un fronte laico, trasversale e apartitico – proprio come il
fortunato modello francese al quale partecipano anche tanti esponenti
stessi della comunità omosessuale – a difesa non solo del concetto di
famiglia ma anche dell’impianto sociale che da questa proviene.
martedì 23 luglio 2013
Pasolini tra eresia e genialità...
di Mario M. Merlino (ereticamente.net)
Nel 2010, per la casa editrice Vallecchi, esce il libro dal titolo Una
lunga incomprensione con sotto titolo Pasolini fra Destra e Sinistra.
Gli autori sono il giornalista Adalberto Baldoni e Gianni Borgna, che fu
assessore alla cultura del comune di Roma sotto la giunta Veltroni. La
presentazione ufficiale, si alternano al microfono il sindaco Alemanno e
Walter Veltroni, si svolge nella prestigiosa sala con i quadri di
Pietro da Cortona in piazza del Campidoglio. Fra gli autorevoli invitati
– per l’occasione mi sono messo la giacca, ma non la cravatta – il
sottoscritto. Al termine gli autori mi autografano la copia, mentre
Walter Veltroni mi guarda con occhio cupo e malevolo quando Adalberto mi
cita nel suo intervento.
Nell’indice dei nomi compaio ripetutamente – e ne darò spiegazione in
questo mio intervento. Più volte Baldoni mi aveva telefonato e, mi
sembra, sia anche venuto una volta a casa. Ci conosciamo dall’ottobre
del 1960, da quando cioè andai ad iscrivermi a La Giovane Italia in via
Quattro Fontane e lui ne era il responsabile provinciale. Poi, certo, le
strade si sono divise e, in alcuni casi (al congresso di Pescara 1965,
ad esempio), sono entrate in conflitto fra loro, ma mai venendo meno
però la reciproca stima. Anzi, di più, negli anni successivi alla mia
scarcerazione, mentre molti evitavano perfino il saluto o per viltà
congenita o per reiterate e in malafede accuse, fu sempre cortese e mi
inviò un affettuoso e spontaneo biglietto alla morte di mio padre. E
queste sono cose che si ‘devono’ ricordare…
L’incomprensione verso Pasolini è nota: verso la sua omosessualità,
quella che lo porterà alla morte (al di là di suggestive interpretazioni
su possibili moventi per un omicidio programmato), a cui va – mi sembra
– in folle e disperata ricerca, dove la destra si fa interprete, e
prona, dei pregiudizi di una borghesia ammantata dal trinomio ‘dio
patria e famiglia’ che, con l’americanismo, ne conserva le parole
svuotate ormai d’ogni contenuto; la sinistra, bigotta ideologicamente
prigioniera di un marxismo dispregiatore del Lumpenproletariat ( quei
‘ragazzi di vita’ delle borgate che Pasolini eleva a mito altro al mondo
operaio bramoso di consumismo e libero nel gergo dalla lingua dominante
quale prodotto borghese) e in concorrenza con la chiesa da cui media
però la medesima mentalità ‘perbenista’.
D’altronde, quando inizia la collaborazione su Il Corriere della Sera
con gli Scritti corsari manifesterà tutta la sua eresia e con
intuizioni, poetiche astratte forse, ma voce di una genialità tanto che,
secondo gli epigoni della beat generation USA, può essere considerato
fra i massimi poeti del ‘900. E ne aveva già dato molteplici segnali fra
cui quella in cui s’era scagliato contro gli studenti a Valle Giulia, 1
marzo del ’68, accusati d’essere figli della borghesia, di razza
prepotente e cattiva (Adriano Romualdi, su altro fronte, ci definirà i
pulcini partoriti dall’uovo marcio della borghesia). Io rimango convinto
che avessero entrambi torto, ma questa è altra storia…
E’ il 7 gennaio 1973 ed egli inaugura la nuova rubrica sul Corriere con
un articolo dal titolo Contro i capelli lunghi, che si concludeva:
‘Provo un immenso e sincero dispiacere nel dirlo (anzi, una vera e
propria disperazione): ma ormai migliaia e centinaia di facce di giovani
italiani, assomigliano sempre più alla faccia di Merlino…’ Bontà sua! E
mia, mi permetto d’aggiungere, che non conosco rimpianti e rancori…
Nel libro raccontavo ad Adalberto – e lui fedelmente, com’è nel suo DNA,
ne riportava il contenuto – di quando s’era deciso di contestarlo,
primi anni ’60, nei pressi della Casa dello studente, dove era stato
invitato a tenere una conferenza, tirandogli contro un secchio di merda.
E di come ci avesse inseguito mentre, rimasti in due o tre, ci si
andava a ficcare a San Lorenzo, quartiere precluso ad ogni nostra
presenza. In quella occasione, di sicuro consapevole della valenza
politica del nostro gesto, egli non ci gridò alle spalle ‘Al fascista!’
ma un reiterato ‘Al ladro! Al ladro!’ che ci salvò da un assicurato
linciaggio. Era l’ombra del fratello Guido, ‘morto giovanetto’, a
spingerlo, non lo saprò mai. Di quel fratello, assassinato nella malga
di Porzùs dai comunisti al servizio degli slavi del IX Korpus, il 7
febbraio del 1945, in quanto partigiano della Divisione Osoppo contraria
all’espansione dei titini oltre la linea del Tagliamento.
Qui, però, voglio ricordare l’ultima sua poesia, scritta in friulano
(1974) l’anno della sua morte, nella raccolta La nuova gioventù.
S’intitola Saluto e augurio ed è rivolta ad ‘un fascista giovane,/ avrà
ventuno, ventidue anni:/ è nato in un paese/ e è andato a scuola in una
città’. E lo esorta: ‘Difendi i paletti di gelso o di ontano,/ in nome
degli Dei, greci o cinesi./ muori d’amore per le vigne./ Per i fichi
negli orti. I ceppi, gli stecchi./ Per il capo tosato dei tuoi
compagni./ Difendi i campi tra il paese/ e la campagna, con le loro
pannocchie/ abbandonate. Difendi ii prato/ tra l’ultima casa del paese e
la roggia./ I casali assomigliano a Chiese:/ godi di questa idea,
tienla nel cuore./ La confidenza col sole e con la pioggia,/ lo sai, è
sapienza santa./ Difendi, conserva, prega!’.
Non si tratta di proporre un Pasolini e di ciò che veramente ha amato.
Si abbandoni lo stupido gioco di mettere agli uni la camicia rossa, ad
altri la camicia nera. Lasciamo a ciascuno di noi ciò in cui abbiamo
creduto, errori e ambiguità comprese. Penso a quella straordinaria
intervista televisiva che egli realizzò ad Ezra Pound, offrendosi
attento rispettoso discepolo, quasi come un figlio con il padre
ritrovato. ‘Abbiamo una linfa e una radice in comune/ stabiliamo un
patto fra noi’… Irrisolta e irrisolvibile risposta di quella notte
quando mi urlò dietro quel ‘al ladro!’… mentre avrebbe atteso la vigilia
della sua morte per aggiungere, rivolgendosi ad uno sconosciuto giovane
fascista, ‘…dì/ di non essere borghese…’ e ancora: ‘Destra (e lo scrive
con la maiuscola) divina/ che è dentro di noi…’.
lunedì 22 luglio 2013
Bruce Lee, a quarant'anni dalla morte...
di Guido Liberati
Il 20 luglio di quarant’anni fa veniva stroncato da un edema cerebrale
Bruce Lee. L’eroe cinematografico vitalista e ribelle, divenne leggenda a
33 anni, fedele al motto che muore giovane chi è caro agli dei. Era
nato a San Francisco nel 1940 durante una tournée negli Stati Uniti
della compagnia della quale facevano parte i suoi genitori. Gran parte
dell’adolescenza la trascorse fra Hong Kong e gli Stati Uniti dove
studiò al Washington State College.
Laureato in filosofia aveva insegnato le arti marziali della lotta ad
attori e registi. Ai suoi funerali parteciparono venticinquemila
persone: James Coburn e Steve McQueen che erano stati suoi allievi ne
portarono la bara al cimitero di Seattle dove venne sepolto. Morì
all’apice del successo in circostanze mai del tutto chiarite, dopo che
era riuscito a girare a Hollywood, I tre dell’operazione Drago: sino ad
allora aveva interpretato a Hong Kong i suoi pochi film diretti da Lo
Wei, Il furore della Cina colpisce ancora,Dalla Cina con furore, L’urlo
di Chen terrorizza anche l’Occidente. Dopo la sua morte, altri film
vennero messi insieme montando materiali televisivi.
Se fu stroncato in vita dai critici cinematografici, gli stessi che oggi
osannano i film di Quentin Tarantino, incarnò nei suoi personaggi
l’archetipo dell’eroe che rifugge dalla violenza, ma che è costretto a
percorrerla come unica strada. Per uno strano destino, suo figlio
Brandon, interprete di un film sulla vita del padre, è morto
tragicamente sul set di un film, anche lui giovanissimo.
Bruce Lee resta un’icona intramontabile dell’immaginario giovanile
(ancora oggi seconda solo a Che Guevara nella “top list” delle magliette
più vendute) attraversando ideologie e culture agli antipodi. Non a
caso la prima statua gli è stata dedicata nella ex Jugoslavia, a Mostar,
mentre proprio oggi ne è stata inaugurata una nuova a Los Angeles dove è
stata scoperta una torreggiante statua dell’attore posta “a guardia”
della Chinatown cinese che per l’occasione celebra i suoi 7 anni di
autonomia amministrativa.
Quella più famosa è a Hong Kong, dove oggi si tiene una giornata
celebrativa con decine di migliaia di partecipanti. Dalla Cina agli
Stati Uniti: con amore più che con furore.
domenica 21 luglio 2013
Se in Alto Adige lo Stato non riesce a difendere “l’italiano”...
tratto da Barbadillo.it
Territori irredenti, minoranze linguistiche e italianità sono temi che hanno, da sempre, infiammato l’agone politico del Bel Paese. In Alto Adige il dibattito sull’identità della popolazione è continuamente acceso e, da parte dell’etnia tedesca, portato avanti a colpi di provocazioni e azioni al limite della costituzionalità. In provincia di Bolzano, infatti, recentemente è stato approvato un provvedimento che ha lo scopo di cancellare i toponimi italiani dalle carte geografiche, dando quindi un colpo di accelerazione alla mai nascosta volontà di cancellare il diritto di esistere alla minoranza di lingua italiana.
È un’azione antistorica sulla quale i media “ufficiali” hanno steso un velo di silenzio, così come hanno totalmente ignorato la mozione parlamentare di Fratelli d’Italia, che voleva vincolare il governo Letta a portare avanti un ricorso al Tar contro la provincia di Bolzano, iniziato dal precedente governo. La mozione è stata bocciata dalla Camera e, pare, la motivazione sia da ricercarsi in un accordo pre-elettorale fra PD e SVP (il Partito del Popolo Sud Tirolese, per dirla in italiano), per cui in caso di vittoria il PD si sarebbe speso per rivedere il ricorso. È passata invece un’altra mozione, più blanda, in cui il governo viene impegnato a sedersi al tavolo delle trattative con la provincia di Bolzano, votata dal neo- arco costituzionale delle larghe intese, incluso l’SVP.
Fratelli d’Italia dal canto suo si dice delusa dalla questione. Secondo Giorgia Meloni, “Il Parlamento si pone giustamente il problema di difendere qualunque minoranza ma non riesce a tutelare la minoranza di lingua italiana in alto Adige. E una nazione che non riesce a difendere i suoi figli, la sua cultura, la sua identità non può definirsi tale”. Dall’altra parte invece gli Schuetzen, i separatisti “sudtirolesi” (per l’etnia di lingua tedesca infatti la zona è Sud Tirolo e non Alto Adige) si dicono delusi dal comportamento dell’SVP, che lascerebbe aperta la porta alle ingerenze romane in “affari che riguardano solo la provincia di Bolzano”.
Territori irredenti, minoranze linguistiche e italianità sono temi che hanno, da sempre, infiammato l’agone politico del Bel Paese. In Alto Adige il dibattito sull’identità della popolazione è continuamente acceso e, da parte dell’etnia tedesca, portato avanti a colpi di provocazioni e azioni al limite della costituzionalità. In provincia di Bolzano, infatti, recentemente è stato approvato un provvedimento che ha lo scopo di cancellare i toponimi italiani dalle carte geografiche, dando quindi un colpo di accelerazione alla mai nascosta volontà di cancellare il diritto di esistere alla minoranza di lingua italiana.
È un’azione antistorica sulla quale i media “ufficiali” hanno steso un velo di silenzio, così come hanno totalmente ignorato la mozione parlamentare di Fratelli d’Italia, che voleva vincolare il governo Letta a portare avanti un ricorso al Tar contro la provincia di Bolzano, iniziato dal precedente governo. La mozione è stata bocciata dalla Camera e, pare, la motivazione sia da ricercarsi in un accordo pre-elettorale fra PD e SVP (il Partito del Popolo Sud Tirolese, per dirla in italiano), per cui in caso di vittoria il PD si sarebbe speso per rivedere il ricorso. È passata invece un’altra mozione, più blanda, in cui il governo viene impegnato a sedersi al tavolo delle trattative con la provincia di Bolzano, votata dal neo- arco costituzionale delle larghe intese, incluso l’SVP.
Fratelli d’Italia dal canto suo si dice delusa dalla questione. Secondo Giorgia Meloni, “Il Parlamento si pone giustamente il problema di difendere qualunque minoranza ma non riesce a tutelare la minoranza di lingua italiana in alto Adige. E una nazione che non riesce a difendere i suoi figli, la sua cultura, la sua identità non può definirsi tale”. Dall’altra parte invece gli Schuetzen, i separatisti “sudtirolesi” (per l’etnia di lingua tedesca infatti la zona è Sud Tirolo e non Alto Adige) si dicono delusi dal comportamento dell’SVP, che lascerebbe aperta la porta alle ingerenze romane in “affari che riguardano solo la provincia di Bolzano”.
sabato 20 luglio 2013
Fmi brûlé. Ricetta in salsa magiara...
di Ugo Gaudenzi (Rinascita)
L’Ungheria di Viktor Orban non è affatto un’animale domestico. Non soltanto ha rivendicato i suoi diritti nazionali di dotarsi di una Costituzione senza briglie a Bruxelles o altrove, non soltanto ha più volte sollevato un netto rifiuto ad assoggettarsi alle politiche di rigore imposte dalla Troika urbi et orbi, non soltanto ha reimposto una sorta di “nazionalizzazione” della propria Banca centrale... ma ora ha anche deciso sia di pagare al più presto, nove mesi prima della scadenza, il suo prestito usuraio contratto con il “mecenate” Fmi, e sia di annunciare la chiusura degli uffici di rappresentanza del Fondo Monetario insediati a Budapest.
L’Ungheria di Viktor Orban non è affatto un’animale domestico. Non soltanto ha rivendicato i suoi diritti nazionali di dotarsi di una Costituzione senza briglie a Bruxelles o altrove, non soltanto ha più volte sollevato un netto rifiuto ad assoggettarsi alle politiche di rigore imposte dalla Troika urbi et orbi, non soltanto ha reimposto una sorta di “nazionalizzazione” della propria Banca centrale... ma ora ha anche deciso sia di pagare al più presto, nove mesi prima della scadenza, il suo prestito usuraio contratto con il “mecenate” Fmi, e sia di annunciare la chiusura degli uffici di rappresentanza del Fondo Monetario insediati a Budapest.
Messa
all’indice dalla “troika” (Fmi, Bce, Ue) subito dopo l’assunzione del
potere da parte del partito di Orban dichiarato “populista” nonché
soggetto alle influenze “negative” della forte destra radicale degli
Jobbik, l’Ungheria aveva già “risposto” alle critiche dei padroni-soloni
facendo fronte al problema del debito (contratto con l’usura
internazionale dal precedente governo), portando detto indebitamento al
di sotto del 3% sul suo Pil già a fine 2011.
Con
metodi subito ritenuti “non ortodossi” dalla grande finanza
internazionale e dai suoi portaparola. E cosa aveva mai deciso il
governo Orban (sostenuto da una larghissima maggioranza parlamentare)?
Di
abbattere il debito con una serie di misure temporanee, una tantum,
capaci di aumentare ex abrupto le entrate. Quali? Naturalmente quelle
più ostiche alle centrali finanziarie.
Le
elenchiamo: 1) tassa sui profitti bancari; 2) nazionalizzazione dei
“fondi pensione” e assicurativi; 3) imposte sulle multinazionali
operanti in territorio magiaro.
E
così, con una lettera inviata questo 15 luglio a Christine Lagarde,
direttore generale del Fmi, György Matolcsy, il governatore della Banca
Centrale ungherese, ha annunciato che Budapest sarà pronta ad estinguere
anticipatamente il debito contratto nel 2008 (20 miliardi di euro) nel
bel mezzo dell’inizio della crisi esportata in Europa dal Lord
Protettore dell’Ue, gli Stati Uniti d’America. E questo grazie
all’avvenuta graduale riassunzione della propria sovranità nazionale,
monetaria, fiscale, finanziaria.
Interessante
è ricordare che nel 2011, a febbraio, il governo Orban - dopo aver
traccheggiato sulle pressanti richieste della Troika di rinegoziare il
debito (con un ulteriore debito: il “metodo” usuraio principe al quale,
per esempio, la nostra stessa Italia si è graziosamente assoggettata) -
riusciva a piazzare senza alcuna intermediazione internazionale le
proprie obbligazioni di Stato, dimostrando che quando si è sovrani e
quindi affidabili i problemi si risolvono normalmente.
Ma
torniamo a questa metà di luglio. Nella sua lettera alla Lagarde,
György Matolcsy, ha annunciato il pagamento anticipato delle prossime
ultime tre rate trimestrali, per un totale di 2 miliardi e 125 milioni
di euro, sottolineando - non si sa quanto ironicamente o sinceramente -
che tale risultato è un effetto, sì, della buona crescita ungherese, ma
anche “degli sforzi personali (della Lagarde) di promozione dello
sviluppo economico”.
Non
male, non male. Peccato che l’esempio magiaro sia per l’Italia-colonia
dei Letta e dei Saccomanni (e dei loro mentori, Prodi e Draghi) quanto
di più siderale mai si possa pensare. Oggi. Domani è però un altro
giorno.
giovedì 18 luglio 2013
Le idee a destra restano ma vanno perseguite con altri mezzi...
di Mario vattani per barbadillo.it
Dopo l’armistizio firmato a bordo della USS Missouri il 2 settembre del
1945, il comando delle forze di occupazione americane, che aveva fatto i
conti con gli ultimi mesi di disperata difesa giapponese da isola a
isola, da scoglio a scoglio, si accorse con meraviglia – e immaginiamo
con un certo sollievo – che non era stata organizzata nessuna resistenza
contro l’invasore, nessuna guerra a oltranza, nessuna “insurgency”.
Il Giappone aveva voltato pagina. La guerra era persa, e soprattutto era finita. Punto.
In Italia è stato molto diverso: la sconfitta completa della resistenza
alle forze di occupazione, degli “insorgenti” più o meno organizzati,
degli ex-combattenti ormai ultraottantenni e dei loro nipoti e pronipoti
– compresi i pronipoti associati per simpatia se non per storia
familiare – è avvenuta solo il 25 febbraio 2013.
Quel giorno si è compreso che l’elettorato, anche per motivi anagrafici,
aveva definitivamente perso interesse per ogni rivendicazione storica.
Non solo per ignoranza o disattenzione, semplicemente per la palese
inutilità del dibattito. Soprattutto però, l’elettorato aveva perso
interesse e fiducia in una comunità che umanamente o idealmente
proveniva direttamente dalla guerra civile ’43-45. Una comunità più che
un corpo politico, che lentamente si era andata assottigliando, e aveva
progressivamente perso – oppure rinunciato a – riferimenti, simboli,
idee, visione d’insieme. Voti.
Per carità, ci dicono sempre che le idee rimangono, ed è vero. Rimane
certamente anche la rivendicazione storica, e quella lasciamola ai
professionisti. Ma la forma-partito prevede la mobilitazione numerica, e
quella, lo abbiamo visto, non c’è. La mobilitazione numerica ha bisogno
di idee trainanti, e quelle che ci sono non trainano. A meno che
qualcuno non creda seriamente che, con una storia politica e culturale
come la nostra, si debba scendere nel fango e accapigliarsi su
matrimonio omosessuale o altri temi cosiddetti etici. Certo si può fare.
Potrei farlo anche io, ma prima dovrei ubriacarmi.
Intanto, in questo periodo di momentanea sospensione, mentre aleggia
ancora il pulviscolo di un mondo esploso,vediamo in tutta Italia, in
molti appuntamenti, quella comunità umana rincontrarsi, riparlarsi. Sono
appuntamenti quasi furtivi. Non se ne legge notizia, ma è per assenza
di interesse del pubblico. Incontri praticamente invisibili: senza
stampa, per mancanza di numeri, di peso politico, di novità.
Già perché nessuna colonna motorizzata di occupanti si è mai fermata per
un gruppo di reduci, stanchi e non più giovanissimi, riuniti in un
vecchio salone a discutere di come sono andate le cose. Naturalmente
parlo a titolo personale, ma di fronte a questo palcoscenico,
un’alternativa c’è.
Arrendersi. Dichiarare la resa. Aspettare il proprio turno, in silenzio,
sul ponte della USS Missouri. Perché c’è qualcosa di purificatorio
nella resa. Arrendersi significa ammettere una sconfitta pratica,
tecnica, numerica. E basta.
Attenzione: la resa non implica la rinuncia alle proprie idee. Anzi,
forse in quel modo le idee diventano addirittura più pure, sublimi.
Forse la resa è l’unico modo per proteggere il nucleo duro della propria
identità. Perché chi si arrende non rinuncia alla sua anima, e nemmeno
ai propri sogni. La regola è semplice: l’importante è arrendersi solo
quando si è perso veramente. Che non si pensi mai che si poteva ancora
resistere.
Poche immagini teatrali sono deprimenti quanto quella del vecchio
soldato stremato, che cerca lo scontro con un nemico che lo ignora.
L’idea della resistenza a oltranza la conosciamo. Ma conosciamo anche la
parola composta che unisce il tragico al comico. Molti italiani
sembrano apprezzare quella parola e quell’immagine, e la trovano
addirittura commovente. Per me invece è uno dei lati dell’Italia che non
riconosco e non apprezzo, nello stesso modo in cui non credo di aver
mai pronunciato l’esclamazione “mammamia” o detto “buono buono” col dito
infilato nella guancia.
Le idee rimangono, sono splendide, e vanno portate avanti con altri
mezzi, nella cultura, nell’arte. E’ lì che le regole sono completamente
diverse, è lì che le forze di occupazione del pensiero unico e del
“politically correct” sono più deboli, dove i cingoli dell’omologazione
scivolano perché trovano la vera, lucida, libertà. E’ lì che le
commissioni di epurazione inciampano da sole nel loro stesso
vocabolario. E’ lì che si sposta il conflitto. Lì c’è ancora un
arsenale. Lì si riparte da capo.
“Ci rivediamo alla prossima”.
mercoledì 17 luglio 2013
Le prudenti autorità di Belfast: “Niente sciarpe e bandiere per Cliftonville-Celtic”
di Michele Chicco (Barbadillo.it)
«Nascondete le vostre sciarpe e ammainate le vostre bandiere»: è questo il consiglio spassionato
che le autorità di Belfast hanno dato ai tifosi del Celtic arrivati in città per il secondo turno preliminare di Champions League da giocare, stasera, contro il Cliftonville. Al Solitude Stadium le due squadre, entrambe storicamente tifate da cattolici repubblicani, si contenderanno il passaggio del turno, ma quello che fa tremare i polsi alle autorità nordirlandesi è ciò che potrebbe succedere prima del match, con gli scozzesi in giro in quelle strade della capitale abitate da protestanti e lealisti.
In una città eternamente divisa, infatti, una partita di pallone rischia di diventare scenografia perfetta per riaccendere antiche passioni, soprattutto se viene giocata pochi giorni dopo la tradizionale marcia degli Orangisti che ha dato il via a quattro notti scontri in Irlanda del Nord. David Begley, dirigente del Cliftonville, ha detto che è solo un consiglio, ma sarebbe bene che i tifosi del Celtic lo seguissero per evitare di rovinare la loro trasferta: «il centro di Belfast – ha aggiunto – è un posto accogliente, ma la gente è molto sensibile ai colori» ed il problema è tutto lì.
Il bianco-verde che avvolge la maglia del Celtic, e le sciarpe dei suoi tifosi, è il simbolo della lotta per un’Irlanda unita, repubblicana e cattolica. Dall’anno della sua fondazione, il Celtic Glasgow ha rappresentato i migranti irlandesi di tutto il mondo e, nelle sei contee del Nord che i britannici non hanno mai pensato di abbandonare, la squadra cattolica di Glasgow è stata adottata come ‘undici’ del cuore dai volontari ribelli dell’IRA. Lo sanno tutti: basta affacciarsi al Celtic Park ed ascoltare i canti indomiti in memoria degli Strikers per capire come, da quelle parti, Glasgow sia molto più vicina a Dublino, Derry e Belfast che a Londra.
Ai protestanti e ai lealisti, però, tutto questo non piace e sono pronti a dar battaglia per difendere l’unicità del Regno. Chi gestisce la sicurezza in Irlanda del Nord conosce il pericolo e vuole evitare a tutti i costi eventuali contatti tra le centinaia di tifosi degli Hoops arrivati a Belfast e gli unionisti britannici. Ai ragazzi di Glasgow, infatti, non solo è stato chiesto di non mostrare i colori del Celtic in giro per la città, ma addirittura c’è chi vorrebbe “relegare”, oggi pomeriggio, i bianco-verdi nel quartiere cattolico di West Belfast e far scortare i taxi dei tifosi fino al Solitude Stadium; come se bastasse vietare alcune strade e far nascondere una sciarpa per zittire un secolare canto di libertà.
«Nascondete le vostre sciarpe e ammainate le vostre bandiere»: è questo il consiglio spassionato
che le autorità di Belfast hanno dato ai tifosi del Celtic arrivati in città per il secondo turno preliminare di Champions League da giocare, stasera, contro il Cliftonville. Al Solitude Stadium le due squadre, entrambe storicamente tifate da cattolici repubblicani, si contenderanno il passaggio del turno, ma quello che fa tremare i polsi alle autorità nordirlandesi è ciò che potrebbe succedere prima del match, con gli scozzesi in giro in quelle strade della capitale abitate da protestanti e lealisti.
In una città eternamente divisa, infatti, una partita di pallone rischia di diventare scenografia perfetta per riaccendere antiche passioni, soprattutto se viene giocata pochi giorni dopo la tradizionale marcia degli Orangisti che ha dato il via a quattro notti scontri in Irlanda del Nord. David Begley, dirigente del Cliftonville, ha detto che è solo un consiglio, ma sarebbe bene che i tifosi del Celtic lo seguissero per evitare di rovinare la loro trasferta: «il centro di Belfast – ha aggiunto – è un posto accogliente, ma la gente è molto sensibile ai colori» ed il problema è tutto lì.
Il bianco-verde che avvolge la maglia del Celtic, e le sciarpe dei suoi tifosi, è il simbolo della lotta per un’Irlanda unita, repubblicana e cattolica. Dall’anno della sua fondazione, il Celtic Glasgow ha rappresentato i migranti irlandesi di tutto il mondo e, nelle sei contee del Nord che i britannici non hanno mai pensato di abbandonare, la squadra cattolica di Glasgow è stata adottata come ‘undici’ del cuore dai volontari ribelli dell’IRA. Lo sanno tutti: basta affacciarsi al Celtic Park ed ascoltare i canti indomiti in memoria degli Strikers per capire come, da quelle parti, Glasgow sia molto più vicina a Dublino, Derry e Belfast che a Londra.
Ai protestanti e ai lealisti, però, tutto questo non piace e sono pronti a dar battaglia per difendere l’unicità del Regno. Chi gestisce la sicurezza in Irlanda del Nord conosce il pericolo e vuole evitare a tutti i costi eventuali contatti tra le centinaia di tifosi degli Hoops arrivati a Belfast e gli unionisti britannici. Ai ragazzi di Glasgow, infatti, non solo è stato chiesto di non mostrare i colori del Celtic in giro per la città, ma addirittura c’è chi vorrebbe “relegare”, oggi pomeriggio, i bianco-verdi nel quartiere cattolico di West Belfast e far scortare i taxi dei tifosi fino al Solitude Stadium; come se bastasse vietare alcune strade e far nascondere una sciarpa per zittire un secolare canto di libertà.
martedì 16 luglio 2013
Rifiutare il Debito è possibile. Islanda chiama Italia...
 di Daniel Tarozzi (ilcambiamento.it)
di Daniel Tarozzi (ilcambiamento.it)
Dall’8 luglio è possibile acquistare
“Islanda chiama Italia – Storia del paese che rifiutò il debito”,
inchiesta di Andrea Degl’Innocenti sulla rivoluzione islandese, primo
libro in italiano sull’argomento, edito da Ludica S.n.c..
Andrea Degl'Innocenti è andato in Islanda per indagare in modo approfondito il 'caso islandese'...
Il Cambiamento è nato quasi tre anni fa. Da allora ha cercato di portare
avanti un'informazione davvero indipendente e fuori dalle logiche che
guidano i mass media. Per farlo si è poggiato sulla collaborazione di
decine di giornalisti giovani e preparati che hanno ricambiato la
fiducia riposta in loro in modo egregio. Tra questi spicca Andrea
Degl'Innocenti che da subito ha saputo volgere il suo occhio attento
verso le vene pulsanti del nostro Paese, del nostro mondo, indagando e
mostrando ciò che troppo spesso veniva nascosto.
Tra le sue tante indagini, la più "famosa" è stata quella sul caso
islandese: un Paese che ha "rifiutato" di pagare il debito, innescando
un processo demcoratico senza precedenti, in cui il popolo ha saputo
davvero scegliere una parte importante del proprio futuro, scavalcando
poteri politici e finanziari.
I suoi articoli sul tema sono stati letti da decine di migliaia di
persone. Andrea ha quindi deciso di andare (a sue spese) in Islanda per
indagare in modo più approfondito la questione ed ha preparato un testo
che da ieri è disponibile in versione elettronico (pdf e epub). Sto
parlando del suo “Islanda chiama Italia – Storia del paese che rifiutò
il debito”, edito da Ludica.
Il libro comprende una prefazione di Loretta Napoleoni economista di
fama internazionale, e si avvale dei contributi di Serge Latouche,
teorico della decrescita, Pierluigi Paoletti , fondatore doi Arcipelago
SCEC, Marco Bersani, del Forum dei movimenti per l’acqua.
Andrea ci racconta l’ascesa e la caduta del sogno islandese , dalla
nascita della società neoliberale fino alle vicende più recenti, che
hanno visto gli abitanti dell’isola ribellarsi contro i propri
governanti corrotti, contro i banchieri senza scrupoli responsabili del
collasso del paese, contro l’intera comunità internazionale che
pretendeva il pagamento di un debito ingiusto, contratto da banche
private.
Infine, Andrea trae spunto dalle vicende islandesi per offrire una
panoramica di alcune delle realtà più significative che anche in Italia
si adoperano per cambiare la società. Ne emerge un mosaico della
“società del cambiamento”, in cui le realtà in lotta sono tasselli
ideali di un grande movimento. Un’opera di riappropriazione collettiva
del diritto di decidere sul modo e sul mondo in cui vogliamo vivere.
lunedì 15 luglio 2013
Islanda senza Big Mac: chiudono i negozi McDonald's...
Quattro euro e 25 centesimi per un BigMac?Troppo caro, meglio chiudere
che alzare i prezzi. McDonald's sparisce così dall'Islanda, dove la
crisi economica ha fatto raddoppiare i costi in un anno.
Lunedì i tre ristoranti fast-food dell'isola, gestiti in franchising
dalla Lyst, non alzeranno quindi le saracinesche, e saranno al più
presto riconvertiti per servire piatti locali. «I nostri concorrenti
usano tutti carne e lattuga islandese - ha spiegato Magnus Ogmundsson,
amministratore delegato della Lyst - mentre noi dobbiamo portar qui
tutto in volo, dalla Germania». Il crollo della corona, che è scivolata
dell'80% sull'euro nel 2008 scorso e dell'8,1% quest'anno - malgrado i
controlli sui capitali - ha eroso dunque tutti i margini. «Per
recuperarlo avremmo dovuto aumentare i nostri prezzi del 20%», ha
aggiunto Magnus.
Il BigMac di Reykjavik è già oggi tra i più cari al mondo: 3,50 euro,
come in Italia, un po' meno dei 3,80 euro di Svizzera e Norvegia (e gli
1,10 euro del Sud Africa). Portarlo a 4,25 euro, nel pieno di una crisi
molto acuta, sarebbe stato impensabile.
Gli islandesi dovranno ora fare a meno della "M" gialla su campo rosso.
Bloomberg ha sentito alcuni di loro: «Sono contento», ha detto Pall
Vilhjalmsson, che ha descritto McDonald's come «un simbolo del
colonialismo americano» che ha «terrorizzato la cultura alimentare in
tutto il mondo»; mentre a Hreinn Omar Smarason, la catena di fast-food
mancherà molto. Riaprirà, un giorno? Magnus non ha lasciato spazio a
equivoci: «È molto improbabile», ha ammesso.
sabato 13 luglio 2013
Gela: settanta anni dopo Husky la strage alleata dimenticata...
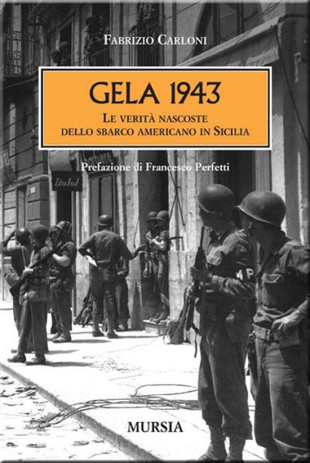
di Marco Petrelli (Barbadillo.it)
A Gela è stata realizzata una coreografia quasi hollywoodiana per ricordare i 70 anni di Husky, lo sbarco anglo americano a Gela e Licata del 10 Luglio 1943.
Ma da quell’angolo di Sicilia torna alla ribalta anche la vicenda triste e
meno nota della della strage di Passo Piazza che costò la vita a 8 carabinieri.
Un crimine di guerra per decine d’anni rimasto avvolto dalla nebbia della
storia ma che ritrova luce grazie a Fabrizio Carloni, ricercatore e giornalista
napoletano (già autore di saggi sulle operazioni alleate in Italia) che è
riuscito a ritrovare un sopravvissuto, Antonio Cianci all’epoca della strage
21 enne carabiniere in servizio in Sicilia.
“Ero sul tetto del casolare – racconta Cianci – e vidi arrivare degli uomini.
Erano le sei, sette del mattino (…) avevo l’ordine, nel dubbio, di sparare,
mirai ad uno e lo uccisi”.
La reazione alleata è durissima. Forse convinti che il nemico sia in gran
numero, i paracadutisti segnalano le coordinate alla flotta che scatena un
inferno. Ancora Cianci: “il vice brigadiere, dopo una coraggiosa resistenza, ci
ordinò di stendere le tovaglie bianche”.
I carabinieri si arrendono ed escono con le mani alzate sotto il tiro dei
Thompson, ma un rumore improvviso fa di nuovo crepitare le automatiche.
Rumori di contadini dai campi, agricoltori oggi anziani che hanno raccontato
a Carloni di “tre carabinieri denudati e massacrati di botte, uno è finito nel
pozzo”.
Cianci finirà invece la guerra in Algeria da prigionieri, dopo tre giorni
trascorsi all’addiaccio.
Il sopravvissuto e lo storico hanno di recente scritto una lettera al
Presidente della Repubblica affinché i morti di Passo Piazza non vengano
dimenticati.
Un evento orribile che forse a Gela in pochi conoscono, malgrado sia simile
in modalità e contemporaneo ad un altro crimine costato 88 morti tra
italiani e tedeschi, la strage dell’aeroporto di Biscari commessa dalla 45^
Divisione di fanteria USA.
*** I libri di Fabrizio Carloni
giovedì 11 luglio 2013
Perdere l’"identità" è perdere la faccia...
di Marcello Veneziani
Ma ha senso,
nell'epoca fluida e globale, appellarsi alle identità personali e
comunitarie, politiche e culturali? Le identità non sono reperti
arcaici, inerti e retorici o, come rozzamente dice qualcuno, cazzate e
baggianate? L'identità è un principio fondamentale in filosofia: è di
derivazione presocratica ma Aristotele fonderà la logica occidentale sul
principio d'identità.
Quella logica su
cui ancora ci basiamo per capire e distinguere. Ma è anche un concetto
usurato nella pratica se ne consideriamo l'uso e l'abuso per rassicurare
le proprie pigrizie, non confrontarsi col mondo, chiudersi nel proprio
recinto. Personalmente preferisco riferirmi a un principio più fluido e
vitale che è la tradizione, dove la continuità implica il mutamento, il
passaggio generazionale di padre in figlio, e dove il senso della
trasmissione non riguarda solo il passato ma anche il futuro. Diciamo
che l'identità sta alla tradizione come la montagna sta al mare. O, con
una formulazione più filosofica, l'identità attiene all'Essere, la
tradizione è l'essere in divenire. Comunque riconoscere l'identità è
riconoscere in ogni persona e comunità non solo i diritti individuali ma
un volto, un'anima e una storia, rispettando nell'identità la sua
dignità.
Un'epoca labile e
mutante come la nostra, segnata dalla velocità e dalla rapida
deperibilità di tutto, principi, legami e consumi, ha bisogno per
contrappeso di punti fermi, di fedeltà che sfidano la precarietà e il
volgere delle mode. Mai come oggi abbiamo bisogno di riscoprire la gioia
delle cose durevoli. È questo, in fondo, il principio che regge il
pensiero conservatore e che qualcuno lo banalizzi e lo ridicolizzi
mortifica la sua intelligenza e il suo spirito liberale ma non scalfisce
la grandezza e il valore di quei principi. È così difficile accettare
che ci sia un pensiero conservatore imperniato sull'identità così come
c'è un pensiero progressista fondato sull'emancipazione? La Tradizione è
un bisogno fondamentale dell'animo umano, almeno quanto lo è il
movimento. All'uomo si richiede duttilità e costanza, e non può
rinunciare a uno dei due o applicarle all'inverso. Ogni società
necessita di assetti stabili e piani mutevoli.
Su queste premesse
va fondato il discorso sulle identità politiche. Nessuno può
ragionevolmente pensare di imbalsamare destra e sinistra - e magari
anche il liberalismo, che non è un'essenza eterna ma una categoria
storica come le altre. E nessuno può pensare di fondare oggi un'identità
politica sul fascismo o sul comunismo. Sono il passato, fanno parte
della memoria. Destra e sinistra si usano solo per capirsi all'ingrosso
ma sono categorie residuali. La politica che non ha contatti con la
storia e la tradizione, con l'etica e i valori, si riduce a quella cosa
miserabile che è sotto i nostri occhi. Se non è animata da passione
civile e ideale si riduce a servitù e meschinità, corruzione e
affarismo.
La politica ha due
compiti fondamentali. Uno è governare un Paese, guidarlo e
amministrarlo, affrontare i problemi pratici, decidere. Ma c'è pure un
altro compito che non è ridicolo o superato, bensì essenziale: la
politica è il luogo in cui le nostre solitudini, le nostre individualità
convergono in uno spazio pubblico e in scelte condivise. Nella politica
si esprimono e si rappresentano i valori pubblici, le visioni comuni e
si fonda la concittadinanza. Intendiamoci, la politica non è l'unico
spazio pubblico che esprime valori condivisi, ci sono altri ambiti,
altre comunità. E poi, accanto allo spazio pubblico, c'è la sfera
privata che riguarda la nostra intimità e le nostre scelte individuali.
La politica è il luogo di sintesi in cui masse di individui si sentono
popolo, partecipano alla vita pubblica, sentono di appartenere a una
polis, pur senza escludere le differenze. Tutto questo non nasce coi
regimi dispotici o con le ideologie totalitarie, come pensano i cronisti
di corte vedute; nasce con la politica, anzi con il pensiero, nasce con
Platone e Aristotele e poi continua nei secoli. Anzi, di più: quel
mondo comune è l'essenza della politica e la base di ogni civiltà.
In quella chiave
assume significato il richiamo politico alle identità. Identità aperte e
non chiuse, mobili e non fisse, identità che si rispettino nelle loro
differenze e non pretendano d'imporsi una sulle altre. La più grande
rivoluzione, benefica e incruenta del Novecento, fu fatta nel nome
dell'identità, della sovranità e della tradizione: dico quella di
Gandhi. Da cui non scaturì un ritorno al passato ma una modernizzazione
armoniosa dell'India. L'identità francese fu il perno della svolta di De
Gaulle e anche la liberale Thatcher compensò il suo liberismo economico
con la difesa conservatrice della tradizione e dell'identità inglese. E
la riunificazione delle due Germanie non fu fondata sul desiderio di
ricucire la ferita di un'identità divisa forzosamente in due?
Che le identità
siano preziose e non sterili o nocive lo dimostra a contrario la loro
assenza nella nostra politica. Quando non ci sono identità da
confrontare, quando non c'è una cultura civica e una tradizione alle
spalle, quando non c'è una civiltà come terreno condiviso, inclusa la
civiltà delle buone maniere, nasce quello schifo di politica e
antipolitica da cui tutti stiamo fuggendo. Le differenze non sono più
fondate sui contenuti, sulle diverse sensibilità, sulle idee o sui temi
concreti della vita; ma su livori, personalismi, banalità e malaffare.
Preferisco dividermi sullo ius soli piuttosto che su Ruby; preferisco
una politica che si differenzi sui contenuti politici e non sui
contenuti delle intercettazioni telefoniche. E poi non veniteci a
raccontare che la tanto invocata rivoluzione liberale è andata a puttane
in Italia a causa di quattro gatti che dicevano di tenere alle
identità... Suvvia, tornate alla realtà.
Certo, al tema
delle identità un liberale è meno interessato e io lo capisco, lo
rispetto e non pretendo che si adegui a questa visione. Per un liberale
contano di più gli individui, i contratti, i mercati. In politica so
distinguere tra la parte e il tutto, so che ci sono culture, e
soprattutto inculture, diverse, anche nel centro destra. Nessuna
reductio ad unum. Chiedo attenzione alle identità, soprattutto da chi ha
fondato la sua ragione politica e il suo consenso su quei temi, ma non
per questo irrido e disprezzo chi è refrattario alle identità. Segua la
sua strada, che non è la mia, ma non pretenda di ridurre le nostre
diversità al suo modo di pensare, ritenendo che sia l'unico moderno,
universale, indiscutibile. Alla fine, questo differenzia chi rispetta la
libertà da chi dice di essere un liberale.
martedì 9 luglio 2013
Famiglia e società (Intervista ad Alain de Benoist)
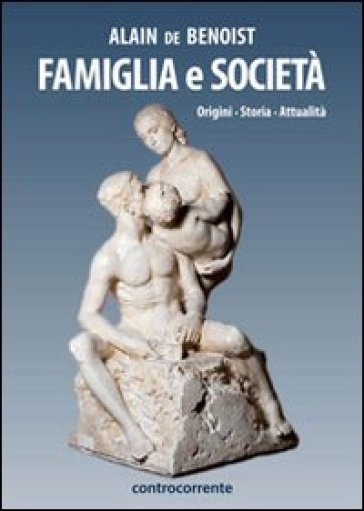
Fiorenza Licitra intervista Alain de Benoist
Fino al X secolo non occorreva un sacerdote per sancire il patto tra
gli sposi; la Chiesa, che ai legami di sangue favoriva la comunità di
fede, non aveva ancora elaborato il predominio giuridico sulla famiglia.
E’ giusto dire che nel tempo il matrimonio si è rivelato uno “strumento
clericale” per fare adepti?
La Chiesa cattolica non si è mai disinteressata del matrimonio, ma di
questo ne ha fatto un sacramento abbastanza tardi, nel XII° secolo.
Controllare il matrimonio era per essa un modo di intervenire nelle
alleanze tra le famiglie e le discendenze. Ma la Chiesa ha anche
ereditato una diffidenza verso il corpo e il sesso, sconfinata, nei
primi secoli della nostra epoca, agli eccessi delle sette encratiste.
San Paolo vedeva nel matrimonio un ripiego, un «rimedio contro la
lussuria»: sposatevi, diceva lui in sostanza, se non siete capaci di
fare altrimenti, cioè di restare vergini. Ciò spiega, nonostante tutto
quello che si possa dire in favore del matrimonio, il modo in cui la
Chiesa ha sempre considerato la verginità uno stato perfetto. Non direi
che il matrimonio è diventato oggi uno “strumento clericale” : la gente
si sposa sempre meno e la pratica religiosa è in crisi. A differenza
dell’Italia, in Francia vi è inoltre un fenomeno particolarmente
accentuato: al momento attuale, un bambino su due nasce fuori dal
matrimonio, proporzione che passa a due bambini su tre nelle grandi
città.
Qual era l’atteggiamento originario della Chiesa rispetto all’aborto?
Nel Medioevo, la Chiesa si rifarà soprattutto all’insegnamento di San
Tommaso D’Aquino, il quale a sua volta aveva adottato il pensiero di
Aristotele rispetto al concepimento e alla gravidanza. Per Aristotele,
il feto non era «animato», cioè realmente dotato di un’anima fin dalla
fecondazione, ma solo dopo qualche settimana. La Chiesa, quindi,
distingueva tra aborto precoce e aborto tardivo, sanzionato molto più
severamente del primo. Quello che la Chiesa ha elaborato sull’anima, non
è che la conseguenza di ciò che l’ha indotta a condannare senza
sfumature tutte le forme d’aborto.
Nonostante la liberalizzazione dei costumi e la disfatta delle
consuetudini, “la medesima origine sociale” resta ancora saldo collante
per la coppia…
Tutti i sociologi sanno che le relazioni che legano due individui non si
basano sull’azzardo. La probabilità di cercare e di trovare un partner
nell’ambiente sociale al quale si appartiene è maggiore che trovarlo
altrove, semplicemente perché non si frequentano altri ambienti. I club
di incontri che si trovano su Internet favoriscono le relazioni sessuali
tra gente di differente appartenenza, ma si tratta di relazioni
difficilmente durevoli. Ben inteso, ci sono sempre le eccezioni. Quando
degli individui di livelli sociali diversi decidono di formare una
coppia, solitamente è l’uomo ad appartenere al ceto superiore:
statisticamente, gli uomini danno meno importanza alla condizione
sociale per la scelta della compagna, perché, prima di tutto, sono
sensibili all’apparenza fisica. Al contrario, tutti i sondaggi rivelano
che lo stato sociale per la donna conta molto, apparendole come una
garanzia di sicurezza. Ma queste osservazioni devono ancora essere
ricollocate in un contesto più esteso. Gli studi generali dei quali si
dispone dimostrano che le coppie più “longeve” sono quelle che si
somigliano maggiormente. E’ l’origine del proverbio: «Chi si assomiglia,
si piglia».
Il Concilio Vaticano II alla procreazione farà prevalere l’unione tra
uomo e donna, quindi il diritto alla felicità. Si può parlare di
“processo di individualizzazione” perseguito dalla Chiesa stessa?
Nel Medioevo, la Chiesa ha favorito una certa individualizzazione dei
comportamenti, nella misura in cui essa ha privilegiato la volontà di
sposare gli individui, in opposizione alle loro rispettive famiglie (un
tempo si chiamava “matrimonio segreto”). Essa ha così ha favorito
un’evoluzione che, a lungo termine, ha portato al “matrimonio d’amore”,
il quale oggi è la principale causa di divorzio: ci si sposa quando si
ama, ci si lascia quando non si ama più. Nell’Antichità, il matrimonio
era prima di tutto un’istituzione riguardante le famiglie. Ecco, la
conseguenza del matrimonio ridotto a contratto tra individui. La Chiesa
ha sempre considerato la procreazione come la finalità profonda del
matrimonio, tuttavia sa bene che certe coppie non possono avere figli,
sia per sterilità, sia a causa dell’età troppo avanzata dei coniugi.
La società (femminile) ha sostituito lo Stato (maschile). Quali sono, a suo avviso, le conseguenze?
Si assiste oggi a un’incontestabile femminilizzazione della società.
Bisogna vedere il risultato di due fattori differenti. In primo luogo
esiste un’evoluzione dei costumi, che tende a stabilire la parità tra
uomo e donna in tutti i domini, restringendo seriamente le antiche
prerogative degli uomini e dei padri in rapporto all’aumento delle
rivendicazioni femministe e al relativo discredito dei valori “virili”.
Inoltre, abbiamo un’evoluzione della stessa struttura sociale, in
particolar modo rispetto alle forme economiche e lavorative. Oggi ci
sono servizi di comunicazione e vario genere (l’aiuto alle persone, le
“attività relazionali”, etc.), che hanno preso sempre più piede nella
struttura economica, contrariamente a una volta in cui il centro di
gravità si ritrovava piuttosto nella sfera industriale. Le qualità
femminili si esplicano meglio nei servizi e nei mestieri della
comunicazione, a differenza delle qualità maschili, dominanti nel mondo
industriale. Le conseguenze di questa femminilizzazione, oltre a un
infiacchimento legale e istituzionale, sono la promozione dei valori
femminili, quali la sensibilità, la cooperazione e il “dialogo”, a
detrimento dei valori maschili, come l’autorità. Questo non è un male in
sé, a condizione che l’equilibrio tra uomo e donna non si rompa e che
la complementarità tra valori maschili e femminili non sia persa di
vista.
Accordare le nozze gay equivale a dire che un domani sarà consentito, a rigor di logica, anche l’adozione di un bambino…
Il matrimonio omosessuale – in Francia “matrimonio per tutti”, locuzione
d’altronde molto abusiva (il matrimonio poligamo e il matrimonio
incestuoso, per citarne un paio, per legge non sono mai stati
autorizzati) – testimonia che il matrimonio ormai non è più percepito
come un’istituzione, ma come semplice contratto tra individui. Innalzare
essenzialmente “l’amore romantico”, e non più la strategia
matrimoniale, significa unire due compagni individuali, anziché
consacrare l’alleanza di due famiglie in seno a un più vasto sistema di
parentela, che assegnava a ciascuno un certo numero di diritti e di
obblighi. In tale ottica, per unirsi, nulla sembra costringere due
individui a essere di sesso differente, visto che la nozione stessa di
sesso (biologicamente) è adesso contestata dall’«ideologia del genere».
Ma lei ha ragione, la stessa rivendicazione di uguaglianza, che ha
portato al matrimonio omosessuale, si estenderà anche all’adozione da
parte degli omosessuali; idem per il riconoscimento delle “madri in
affitto” e per la procreazione assistita. Tali rivendicazioni
d’altronde si esprimano già.
Relativizzare la famiglia comporta anche il relativizzarsi della responsabilità?
Nel principio, lei non ha torto, ma bisogna comprendere che ciò che si
chiama “famiglia” è un concetto notevolmente trasformabile. La famiglia
tradizionale è oggi divenuta un fattore marginale. Le relazioni delle
coppie si sono evolute e le relazioni tra le generazioni sono mutate.
Assistiamo al moltiplicarsi delle “famiglie ricomposte”, cioè di coppie
di genitori che hanno già avuto dei figli da una precedente unione.
Questo fenomeno in Francia tocca più di una famiglia su dieci. Si devono
aggiungere, inoltre, i casi di coabitazione intermittente (o
semi-separazioni) di coppie sposate, cosicché le famiglie monoparentali,
più numerose in Italia, in Francia rappresentano attualmente più del
20% e riguardano tre milioni di bambini. Queste famiglie monoparentali,
nella stragrande maggioranza, sono costituite da donne che vivono sole
con i figli. La famiglia non è più il luogo naturale della
responsabilità; d’altronde, l’autorità del capo famiglia oggi è caduta
in un certo discredito. La responsabilità resta un valore, ma si
esercita nei domini più vari. Piuttosto, sono l’individualismo e
l’egoismo edonistico a rappresentare per essa la principale minaccia.
Cos’è che influenza più la trasformazione della famiglia, la società o la famiglia stessa?
Chi è nato prima, l’uovo o la gallina? Stesso approccio per la famiglia e
la società: esse vanno di pari passo. L’evoluzione della famiglia
riflette l’evoluzione della società, in continuo progresso, e
l’evoluzione della società riflette quella della famiglia. Questa è la
ragione per cui è abbastanza diffusa l’idea secondo la quale una “buona
famiglia” può rappresentare una struttura resistente, un rifugio, un
contrappeso. In rapporto a quello che c’è di più negativo o di più
contestabile nella società attuale, mi sembra però che in parte sia
un’illusione. Quando i bambini raggiungono una certa età, è estremamente
difficile per i genitori opporsi all’influenza del mondo esterno. Ci
sono le eccezioni, ma in generale la famiglia non costituisce che una
linea di resistenza abbastanza minima.
Lei scrive che nelle civiltà indoeuropee la discendenza, l’autorità
del capo di famiglia, il valore dei consanguinei non sono realtà
biologiche, ma entità di ordine spirituale. Al contrario di oggi, che
venendo a mancare tutto questo, la famiglia è inscritta in una
temporalità non più verticale, ma orizzontale?
A questo riguardo, la famiglia non fa eccezione. L’intera società ha
sovvertito la verticalità con l’orizzontalità. Nel dominio dei valori,
il bene e il male non sono più i sinonimi dell’alto e del basso. Nella
vita quotidiana, il «presentismo» consacra il crollo della dimensioni
della profondità, costituente fino a poco tempo fa la chiara coscienza
del modo in cui il passato si congiunge all’avvenire. Più generalmente
ancora, tutto quello che è stato stabile, solido, duraturo tende a
divenire transitorio, passeggero, effimero. Si potrebbe dire,
utilizzando le categorie proposte dal sociologo Zygmunt Baumann, che il
«liquido» ha rimpiazzato il «solido». La logica dei territori, che è una
logica politica e tellurica, ha ceduto il posto a quella del flusso e
del rifiuto, logica commerciale e marittima. Ciò che scompare è prima di
tutto la nozione di durata. La vita familiare ne è direttamente
affetta, giacché la durata media non cessa di abbassarsi. L’instabilità
delle relazioni di coppia si è accentuata parallelamente alla
“flessibilità” delle carriere professionali, come alla volubilità dei
comportamenti elettorali e dei reclutamentipolitici. Nello stesso
momento in cui si entra nell’azienda per «fare carriera», non ci si
sposa più «per la vita». Nelle relazioni sentimentali o sessuali, lo
«zapping» prevale allo stesso modo che nei comportamenti elettorali o
nei modi di fare dei consumatori contemporanei. Siamo di fronte a un
movimento generale, peculiare del momento storico nel quale viviamo.
Come sarà possibile la posterità senza una memoria ancestrale?
In effetti, è bene domandarselo. Io sono di quelli che pensano che il
presente non sia vivibile e, soprattutto, che non può essere dotato di
senso se non alla condizione d’essere sostenuto dalla doppia coscienza
del passato e dell’avvenire. La memoria va di pari passo con la capacità
di sapersi progettare nel futuro. Chi vuole avere passato, si condanna a
non avere futuro.
lunedì 8 luglio 2013
Quella Francia che ci dà l'esempio in piedi...
di Gabriele Adinolfi
Se vi
capita di passare per Parigi o per una qualsiasi città di Francia, ben
167, vi accorgerete che in molte piazze ci sono decine e decine di
persone in piedi, in silenzio, che leggono un libro.
Non è una variante dei mimi, non si tratta di una nuova forma d’arte. E’ l’ultimo grido, anzi l’ultimo non-grido della rivolta popolare.
Non è una variante dei mimi, non si tratta di una nuova forma d’arte. E’ l’ultimo grido, anzi l’ultimo non-grido della rivolta popolare.
Alla legge Toubira, quella del mariage pour tous, metà Francia, almeno, ha risposto scendendo in piazza. Ci sono stati scontri selvaggi perché il governo ispirato al modello dei repubblicani spagnoli ha imposto la repressione. Uomini e donne, giovani e anziani, persone di ogni ceto e di ogni idea politica, hanno retto la piazza. Scontri duri, fermi, arresti.
In particolare il giovane Nicolas è stato chiuso nella prigione di Fleury-Mérogis per delitto d’opinione. E’ scattata allora la protesta popolare; si sono organizzati autonomamente, grazie alla rete, alle radio, e in particolare mediante una pagina facebook.
Hanno deciso di protestare così.
Ininterrottamente, giorno e notte, in tutta la Francia sono a migliaia a stare fermi, in piedi, con un libro in mano, per dimostrare la forza calma di chi ha ragione e la bellezza della libertà.
Ininterrottamente, giorno e notte, in tutta la Francia sono a migliaia a stare fermi, in piedi, con un libro in mano, per dimostrare la forza calma di chi ha ragione e la bellezza della libertà.
Si danno il cambio ininterrottamente, ma restano, ciascuno, diverse ore; saranno quindi svariate decine di migliaia impegnati in questa tormentata battaglia; all’inizio c’è chi ne ha passate più di dodici di seguito per non lasciare il posto.
“Meglio morire in piedi – scrivono – che vivere in ginocchio”.
La tenacia, signori, è madre di tutte le guerre. Forse abbiamo qualcosa da imparare da oltralpe.
venerdì 5 luglio 2013
Si è spenta Maria Pasquinelli, l’insegnante di Pola che uccise il generale De Winton “oppressore” della terra istriana
di Antonella Ambrosioni (Secolo d'Italia)
Si è spenta a Bergamo Maria Pasquinelli. Un nome che ai più giovani dirà poco ma che oggi piangono in molti, tutti i profughi di Istria e Dalmazia e i triestini che conoscono bene la sua storia. Un nome che tutti gli italiani dovrebbero portare nel cuore per la sua dedizione alla causa nazionale, simbolo di tutta la sofferenza, l’amarezza, la rabbia degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Maria Pasquinelli era un’insegnante di Pedagogia originaria della Toscana, già crocerossina in Cirenaica, poi rimpatriata per insegnare a Spalato. Il 10 febbraio del 1947, data infausta della firma del Trattato di Pace, uccise con tre colpi di pistola il comandante della guarnigione britannica di Pola, generale Robert W. De Winton, durante la cerimonia di passaggio dei poteri sul capoluogo istriano alle autorità jugoslave. Immediatamente fermata e condotta al comando, in tasca le venne trovato il seguente bigliettino-confessione: «Mi ribello, col fermo proposito di colpire a morte chi ha la sventura di rappresentarli, ai Quattro Grandi i quali, alla Conferenza di Parigi, in oltraggio ai sensi di giustizia, di umanità e di saggezza politica, hanno deciso di strappare ancora una volta dal grembo materno le terre più sacre d’Italia, condannandole o agli esperimenti di una novella Danzica o con la più fredda consapevolezza, che è correità, al giogo jugoslavo, sinonimo per la nostra gente indomabilmente italiana, di morte in foiba, di deportazioni, di esilio».
Processata davanti alla Corte Militare Alleata di Trieste, la Pasquinelli si dichiarò colpevole e spiegò le ragioni che l’avevano indotta a compiere l’attentato. Il dibattito si svolse senza tumulti né colpi di scena. Il 10 aprile la Corte alleata pronunciava la sentenza di condanna a morte, All’invito della Corte rivolto alla Pasquinelli e al suo avvocato di appellarsi entro trenta giorni la Pasquinelli rispose: «Ringrazio la Corte per le cortesie usatemi, ma fin d’ora dichiaro che mai firmerò la domanda di grazia agli oppressori della mia terra». In numerose città italiane vi furono proteste e raccolte firme, per iniziativa soprattutto della mobilitazione dei giovani del Msi, richiedendo la commutazione della pena. Il 21 maggio 1947, la pena capitale fu infatti commutata in ergastolo e Maria fu trasferita nel penitenziario di Perugia. Nel 1965 tornò in libertà. I polesani dell’Unione degli Istriani furono gli ultimi ad incontrarla lo scorso marzo, quando in occasione del suo centesimo compleanno le regalarono un mazzo di fiori. La sua figura di fedele italiana venne presto dimenticata e il suo gesto venne liquidato come un rigurgito fascista. Ma i cittadini del nostro confine orientale, gli esuli hanno continuato a vedere in lei un esempio di «coerenza assoluta», come spiega il presidente dell’Unione istriani Massimiliano Lacota.
Si è spenta a Bergamo Maria Pasquinelli. Un nome che ai più giovani dirà poco ma che oggi piangono in molti, tutti i profughi di Istria e Dalmazia e i triestini che conoscono bene la sua storia. Un nome che tutti gli italiani dovrebbero portare nel cuore per la sua dedizione alla causa nazionale, simbolo di tutta la sofferenza, l’amarezza, la rabbia degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Maria Pasquinelli era un’insegnante di Pedagogia originaria della Toscana, già crocerossina in Cirenaica, poi rimpatriata per insegnare a Spalato. Il 10 febbraio del 1947, data infausta della firma del Trattato di Pace, uccise con tre colpi di pistola il comandante della guarnigione britannica di Pola, generale Robert W. De Winton, durante la cerimonia di passaggio dei poteri sul capoluogo istriano alle autorità jugoslave. Immediatamente fermata e condotta al comando, in tasca le venne trovato il seguente bigliettino-confessione: «Mi ribello, col fermo proposito di colpire a morte chi ha la sventura di rappresentarli, ai Quattro Grandi i quali, alla Conferenza di Parigi, in oltraggio ai sensi di giustizia, di umanità e di saggezza politica, hanno deciso di strappare ancora una volta dal grembo materno le terre più sacre d’Italia, condannandole o agli esperimenti di una novella Danzica o con la più fredda consapevolezza, che è correità, al giogo jugoslavo, sinonimo per la nostra gente indomabilmente italiana, di morte in foiba, di deportazioni, di esilio».
Processata davanti alla Corte Militare Alleata di Trieste, la Pasquinelli si dichiarò colpevole e spiegò le ragioni che l’avevano indotta a compiere l’attentato. Il dibattito si svolse senza tumulti né colpi di scena. Il 10 aprile la Corte alleata pronunciava la sentenza di condanna a morte, All’invito della Corte rivolto alla Pasquinelli e al suo avvocato di appellarsi entro trenta giorni la Pasquinelli rispose: «Ringrazio la Corte per le cortesie usatemi, ma fin d’ora dichiaro che mai firmerò la domanda di grazia agli oppressori della mia terra». In numerose città italiane vi furono proteste e raccolte firme, per iniziativa soprattutto della mobilitazione dei giovani del Msi, richiedendo la commutazione della pena. Il 21 maggio 1947, la pena capitale fu infatti commutata in ergastolo e Maria fu trasferita nel penitenziario di Perugia. Nel 1965 tornò in libertà. I polesani dell’Unione degli Istriani furono gli ultimi ad incontrarla lo scorso marzo, quando in occasione del suo centesimo compleanno le regalarono un mazzo di fiori. La sua figura di fedele italiana venne presto dimenticata e il suo gesto venne liquidato come un rigurgito fascista. Ma i cittadini del nostro confine orientale, gli esuli hanno continuato a vedere in lei un esempio di «coerenza assoluta», come spiega il presidente dell’Unione istriani Massimiliano Lacota.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)















