di Mauro Scacchi (Centro Studi La Runa)
Due mostri sacri
della letteratura dell’immaginario del XX secolo. Due precursori:
Lovecraft di un peculiare concetto di horror, Tolkien di quel che si può
agevolmente definire fantasy classico. In questa sede si proverà a
tracciare un parallelo, uno studio comparato tra il viaggiatore onirico
americano e il professore inglese. Lacune, mancanze, inesattezze (spero
poche) saranno forse presenti ma la sfida è troppo intrigante per non
accettarla. La visione del mondo di HPL e Tolkien, la loro
Weltanschauung, va analizzata da due prospettive che sono l’una lo
specchio dell’altra: la prima da riferirsi alla vita reale dei due
autori, la seconda alle loro opere. Un’analisi tanto minuziosa e
approfondita richiederebbe un intero volume, perciò qui si passeranno in
rassegna i punti di contatto e le divergenze più importanti, seguendo
velocemente un flusso costituito da coppie di elementi, a volte eguali,
altre molto differenti.
Per iniziare, non è
forse sbagliato asserire che erano entrambi dei conservatori.
Lovecraft, da giovane, era affascinato dall’Islam e dall’età classica
(antichi Romani in particolare) ma poi divenne ateo e materialista.
Tolkien fu un cattolico ma per tutta la vita fu appassionato di saghe
nordiche dal sapore, per così dire, magico e pagano. Entrambi amavano il
mito e non tolleravano la modernità. Entrambi, inoltre, erano incantati
dalla natura. Tanto l’uno quanto l’altro hanno riempito le proprie
produzioni letterarie di nomi inventati fatti risalire a linguaggi
fantasiosi, benché Tolkien fosse un vero creatore in questo senso,
mentre Lovecraft lasciava ai lettori la sensazione che esistessero
lingue morte collegate a terribili culti segreti senza, però, inventare
mai un linguaggio vero e proprio.
In Tolkien vi è la
battaglia eterna tra il bene e il male, ma il primo, anche quando
assediato, non è mai sconfitto nella sua essenza, sempre è presente un
eroismo pregno di speranza, di potenza interiore in grado di scacciare
le tenebre. In Lovecraft invece il male è associato all’ignoranza
rispetto a ciò che abita negli abissi cosmici, creature innominabili di
cui, non appena s’intuisce anche solo l’esistenza, si ha terrore e da
cui perciò si deve assolutamente scappare, pena – nella migliore delle
ipotesi, scrive HPL – la pazzia o la morte. Quindi in Tolkien il bene
vince sul male, mentre in Lovecraft il bene è come un lumicino che si
spegne di fronte all’insondabile minaccia aliena.
 Entrambi
scrissero saggi e poesie in difesa dei generi narrativi cui si
sentivano più vicini. I mondi a cui hanno dato vita sono diversi sotto
molti aspetti: la Terra di Mezzo è l’Europa di un tempo dimenticato,
mentre le ambientazioni lovecraftiane riguardano per lo più il mondo
reale, anche se poi si scopre che esso è pieno di entità oscure che, con
la loro presenza, lo alterano nei suoi significati più profondi. In
Lovecraft il mondo onirico è descritto in modo tale che pare emergere
dalle nebbie di ricordi che sfumano non appena ci si sveglia, e i suoi
abitanti non necessitano di essere inseriti in una cornice dettagliata
poiché la loro funzione è quella di essere delle comparse, quasi ombre
che sfiorano il protagonista nei suoi vagabondaggi. Un’inclinazione
palesemente pessimistica che ha riscontri con la sua vita reale: era un
solitario, malato di nervi (nonché ipocondriaco), sua madre fu una
figura opprimente, il suo matrimonio finì male ed egli si chiuse sempre
più in se stesso. Affermava di non credere a quello che scriveva, ad
altri universi e spiritualità, eppure la sua vita era in quei mondi, in
quegli esseri a cavallo tra il concreto e l’immateriale provenienti da
regioni intermedie e oscure; una vita, la sua, piena di mostri e di
contrizioni spaventose al punto che un’affermazione del genere sembra
più un modo ingenuo per esorcizzare le proprie paure e le proprie
inadeguatezze, che una dichiarazione sincera.
Entrambi
scrissero saggi e poesie in difesa dei generi narrativi cui si
sentivano più vicini. I mondi a cui hanno dato vita sono diversi sotto
molti aspetti: la Terra di Mezzo è l’Europa di un tempo dimenticato,
mentre le ambientazioni lovecraftiane riguardano per lo più il mondo
reale, anche se poi si scopre che esso è pieno di entità oscure che, con
la loro presenza, lo alterano nei suoi significati più profondi. In
Lovecraft il mondo onirico è descritto in modo tale che pare emergere
dalle nebbie di ricordi che sfumano non appena ci si sveglia, e i suoi
abitanti non necessitano di essere inseriti in una cornice dettagliata
poiché la loro funzione è quella di essere delle comparse, quasi ombre
che sfiorano il protagonista nei suoi vagabondaggi. Un’inclinazione
palesemente pessimistica che ha riscontri con la sua vita reale: era un
solitario, malato di nervi (nonché ipocondriaco), sua madre fu una
figura opprimente, il suo matrimonio finì male ed egli si chiuse sempre
più in se stesso. Affermava di non credere a quello che scriveva, ad
altri universi e spiritualità, eppure la sua vita era in quei mondi, in
quegli esseri a cavallo tra il concreto e l’immateriale provenienti da
regioni intermedie e oscure; una vita, la sua, piena di mostri e di
contrizioni spaventose al punto che un’affermazione del genere sembra
più un modo ingenuo per esorcizzare le proprie paure e le proprie
inadeguatezze, che una dichiarazione sincera.
Tolkien era
credente, e comunque mai ha detto né scritto di non ritenere come vera
l’esistenza di una dimensione spirituale. Aveva una famiglia che amava e
da cui era amato. Era un importante professore di Oxford e i suoi
romanzi ebbero un successo incredibile, pur se inaspettato.
Lovecraft, in vita,
ebbe successo solo tra gli “addetti ai lavori”, ma economicamente visse
sempre sulla soglia della povertà e non si laureò dato che i problemi
di salute gli impedivano di recarsi all’università. Tolkien era un uomo
di successo, Lovecraft un emarginato. In breve, si può affermare che il
primo era “aperto” verso la società, nonostante ebbe modo di contestarne
l’eccessiva tecnologia, il secondo era “chiuso”, introverso. Le foto
che li ritraggono danno l’impressione di un Tolkien appagato, con la
pipa in mano seduto comodamente nel salotto di casa sua, e di un
Lovecraft smunto e dalle spalle strette, non proprio la felicità in
persona. Eppure in altre foto, meno note, Lovecraft sorride, e il
sorriso è quello di un ragazzo (altro che “vecchio”, come lui si
sentiva!) ricco di sentimenti, che infatti possedeva e che indirizzava
probabilmente più verso i gatti che verso le persone.
Un elemento che è
presente in entrambi, e non di poco conto, è il fatto che sia per HPL
che per Tolkien i veri protagonisti non erano gli individui che
popolavano le loro storie. Per Tolkien il protagonista, il cardine
assoluto attorno cui tutto ruotava, era il linguaggio. Egli dapprima
inventò una lingua melodiosa, quella elfica (anche se non solo quella),
per poi creare un mondo in cui potesse venir parlata. Ecco allora lo
scritto epico de il Silmarillion, la grande avventura de Il Signore
degli anelli e, prima di questo,Lo Hobbit. Opere in cui Tolkien
descrisse con un’accuratezza impareggiabile, senza risultare mai noiosa,
usanze e tradizioni d’interi popoli: dal modo in cui si vestivano e
mangiavano a quello in cui cavalcavano ed erigevano case e torrioni,
fino alle tecniche di guerra. Elfi, nani, uomini e Dúnedain, e perfino
orchi e trolls vennero inquadrati all’interno di schemi di pensiero e di
vita, per assolvere al compito principale d’utilizzare un certo
linguaggio anziché un altro: musicale e leggiadro per gli elfi, pratico
per gli uomini, gutturale e dal vocabolario limitato per gli orchi, ecc.
Per Lovecraft,
invece, il protagonista era l’orrore. I personaggi delle sue narrazioni
erano gli strumenti e i catalizzatori degli orrori che il lettore doveva
condividere con l’autore: immedesimandosi in essi, si avrebbe provata
la stessa paura, lo stesso brivido gelido di fronte al caos idiota,
fuori da ogni legge di natura, che governa l’universo. La natura, per
HPL, se da un lato è classica e amabile nelle sue forme esteriori e
armoniose, dall’altro è una menzogna che nasconde un’altra natura,
quella che sta alla base di tutta la creazione, terrificante e priva di
senso. Il meccanicismo razionale è, in Lovecraft, uno “specchio per le
allodole” con il quale un’umanità impotente vuol convincere se stessa di
poter dare risposte a quesiti al di là delle proprie capacità di
soluzione; di ciò HPL è l’esempio vivente, è colui che trasferendo sulla
carta le più intime fobie sembra volerle allontanare da sé,
convincendosi di essere al di sopra di esse, non credendo nemmeno alla
loro esistenza, né tanto meno ad una loro personificazione. Il suo
materialismo e ateismo assolvono perciò alla funzione di totem
apotropaici che non gli impediscono, però, di continuare a sognare terre
e creature dell’incubo, le quali, attraverso un processo d’integrazione
del tutto particolare, gli consentono di temere meno quella natura
spaventosa di cui sono emblemi. HPL, con i suoi racconti, smentì
continuamente le proprie convinzioni a-spiritualiste, anzi accostandosi
vieppiù ai propri mostri immaginari iniziò a condividere con essi un
mondo altro rispetto al nostro, la cui percezione in certo qual modo lo
rendeva più simile alle entità descritte nei suoi lavori che non agli
altri esseri umani. Il modello di Pickman, in cui un pittore risulta poi
essere imparentato con i mangiatori di carogne, i ghouls, che dipingeva
sulle sue tele, può ben illustrare questo concetto. In sostanza, il
mondo dell’orrore non è più così terrificante se si inizia a farne
parte.
La natura, per HPL,
è l’essenza stessa dell’orrore. In Tolkien, invece, è paesaggio vivente
(si pensi agli Ent, i «pastori di alberi», più che mai simbolo di una
natura che partecipa attivamente alla vita del mondo); bella e
rigogliosa o scura e terribile, essa è romantica (nel senso del sublime
di byroniana memoria) e riflette l’animo di chi vi è immerso, di coloro
che la abitano. La terra della Contea è curata e produce frutti perché
vi abitano gli hobbits, a differenza delle paludi (moltissime),
pericolose e sinistre, abitate da spiriti inquieti. Ciò che accomuna i
due autori è, senza dubbio, anche l’uso dei simboli. Un uso che,
consapevole o meno, non si può negare: farlo significherebbe offendere
la cultura imponente dei padri dell’horror e del fantasy. I simboli più
manifesti nelle rispettive produzioni sono quelli del viaggio, della
porta, della montagna, delle isole e della selva oscura, ma anche il
mondo crepuscolare e la descrizione delle città sacre. Ve ne sono molti
altri, alcuni caratteristici di un solo autore (come la spada, in
Tolkien), altri comuni come quello della fisiognomica deforme di alcuni
umanoidi (l’abbrutimento interiore dell’individuo?), su cui non ci
soffermeremo. Il viaggio, tanto per cominciare. Esso può essere breve o
lungo ma è sempre un cammino iniziatico. Durante il tragitto, la
Compagnia dell’Anello si sfalda e si ricompatta, acquista consapevolezza
di sé e della propria missione. Ogni tappa ha un colore proprio: il
verde dei boschi, il nero delle miniere, il rosso del Balrog e del Monte
Fato, il blu dei fiumi ecc., ed ogni volta uno o tutti i membri della
Compagnia crescono, spesso immolandosi (come Gandalf e Boromir, ma solo
il primo sarà meritevole di una nuova e più alta incarnazione).
In Lovecraft il
viaggio, anche solo una breve ma perigliosa salita (si pensi aLa casa
misteriosa lassù nella nebbia), ha come meta finale la scoperta
dell’esistenza di antichi segreti, di luoghi e dimensioni ultraterreni,
che inevitabilmente inizia chi lo compie segnandolo per sempre. Il
viaggio è come una strada maestra su cui insistono altri simboli. La
porta, ad esempio, è simbolo di passaggio fin dagli albori dell’umanità.
Porte e cancelli
consentono di entrare in luoghi protetti, ma pure in zone infernali, e
quindi di uscirne (ma sempre dopo aver superato qualche genere di
prova). Il Signore degli anelli è pieno di queste soglie che danno
accesso a veri micromondi e dinanzi alle quali si compiono profezie. Le
porte di Lovecraft sono varchi al di là dei quali vi sono altre
dimensioni. La montagna, come centro del mondo, testimonia epoche
dimenticate, è visibile sin da lontano e giganteggia quando vi si
giunge, è nascondiglio di sapienza segreta e di coloro che gelosamente
la custodiscono. È nei luoghi elevati che accadono molti eventi
portentosi, al pari che nelle loro viscere. L’isola è un altro simbolo
che, pur comparendo poche volte, è fondamentale. Si pensi a Númenor, che
come Atlantide sprofondò per la superbia e l’orgoglio degli antichi re,
e all’isola dove sorge R’lyeh, la città dove dorme Cthulhu, il Grande
Antico. Sono luoghi di potere lontani ma che possono sempre essere
riscoperti da chi sa dove cercarli.
La selva oscura è la foresta tenebrosa, un simbolo su cui non occorre soffermarsi tanto è stato studiato fino ad oggi.
Il mondo
crepuscolare, quello onirico di Randolph Carter e quello dell’ombra in
cui vivono i Nazgûl (e che diviene visibile a chi s’infila l’Unico
anello), è un limbo di congiunzione tra differenti stati di coscienza,
mortale per chi non vi arriva attrezzato. Ma se in Lovecraft esso non è
necessariamente il male, in Tolkien è il territorio degli Spettri, la
negazione della vita che infetta e avvelena gli incauti che vi si
attardano.
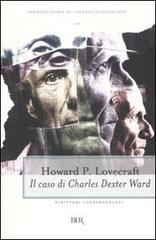 In
ultimo, per quel che ci compete, vi sono le città. In Alla ricerca del
misterioso Kadath di Lovecraft , la città del sogno, difficile da
raggiungere, è descritta secondo lo stile di Lord Dunsany (la città di
Sardathrion in Tempo e gli dei), e l’architettura comprende terrazze
altissime che ricordano, ancora, le montagne; in Tolkien la città per
eccellenza è Minas Tirith (invero, anch’essa difficile da raggiungere),
in cui si può ravvisare il simbolo delle mura concentriche con la torre
svettante nel mezzo, altro “centro del mondo”. Vi sono anche altre città
nella Terra di Mezzo, ognuna con il suo significato (Rivendell, per
esempio, luogo di un’armonia in larga parte perduta tra gli esseri
viventi ed il creato). In HPL le città, in genere, sono però quelle del
New England e sono descritte in modo da evidenziarne la nobile decadenza
al fine di preparare psicologicamente il lettore a ciò che seguirà nel
racconto, solitamente qualcosa di sinistro, di antico eppur pregno di
aristocratica conoscenza (come ne il caso di Charles Dexter Ward)
In
ultimo, per quel che ci compete, vi sono le città. In Alla ricerca del
misterioso Kadath di Lovecraft , la città del sogno, difficile da
raggiungere, è descritta secondo lo stile di Lord Dunsany (la città di
Sardathrion in Tempo e gli dei), e l’architettura comprende terrazze
altissime che ricordano, ancora, le montagne; in Tolkien la città per
eccellenza è Minas Tirith (invero, anch’essa difficile da raggiungere),
in cui si può ravvisare il simbolo delle mura concentriche con la torre
svettante nel mezzo, altro “centro del mondo”. Vi sono anche altre città
nella Terra di Mezzo, ognuna con il suo significato (Rivendell, per
esempio, luogo di un’armonia in larga parte perduta tra gli esseri
viventi ed il creato). In HPL le città, in genere, sono però quelle del
New England e sono descritte in modo da evidenziarne la nobile decadenza
al fine di preparare psicologicamente il lettore a ciò che seguirà nel
racconto, solitamente qualcosa di sinistro, di antico eppur pregno di
aristocratica conoscenza (come ne il caso di Charles Dexter Ward)
Tolkien e
Lovecraft, di primo acchito, non potrebbero sembrare più diversi.
Battaglie epiche ed eroi solari nel primo, viaggiatori solitari il più
delle volte sconfitti e terrorizzati nel secondo; divinità non manifeste
ma alleate degli Uomini in Tolkien, divinità malevole e disgustose
(tranne in un caso: l’antropomorfo Nodens, signore delle profondità) in
HPL. Tutte differenze che, a un esame più attento, si assottigliano fino
a rivelare, in molti casi, somiglianze di fondo. Anche perché ad
accostare questi due autori è una visione mitica del mondo, accompagnata
dal disprezzo di un iperrealismo tanto narrativo quanto esistenziale.
Che si tratti di miti positivi o negativi poco importa. Il mito resta il
tratto distintivo di chi giudica insufficiente e deludente la realtà
che ci circonda, e ciò era vero sia per Lovecraft che per Tolkien.
Sognare, inventare storie, linguaggi e mondi, entrare in contatto con
una dimensione potente e magica: ecco il segreto dei due autori e di
tutti coloro che li hanno letti e che continueranno a farlo.


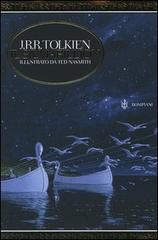
Nessun commento:
Posta un commento